Il Crepuscolo dei divini indici di Wall Street nell’epopea di Stefano Massini
La Lehman Trilogy, ovvero come fare storie con i soldi (e in America ne farebbero un musical...)
L’intervento alla presentazione della Lehman Trilogy di Stefano Massini, al Chiostro “Nina Vinchi” del Piccolo Teatro di Milano, 13 marzo 2014. Il testo verrà allestito nella stagione 2014-15 da Luca Ronconi.
Nella sua densa presentazione di questa Lehman Trilogy Luca Ronconi parla di “un trittico quasi wagneriano, dove l’Oro del Reno di un’Alabama negriera giungerà, inevitabile, al Crepuscolo dei divini indici di Wall Street”.
La saga comincia nel 1844 quando da un paesino bavarese arriva in America Henry Lehman. Poco dopo lo raggiungeranno i fratelli Emanuel e Mayer. Tutti e tre ebrei ortodossi, cominciano l’attività negli stati del Sud, a Montgomery in Alabama, con un negozio prima di tessili e di abbigliamento, poi anche di sementi e attrezzi agricoli. Dopo un devastante incendio delle piantagioni cominciano a farsi pagare la merce in cotone grezzo che poi rivendono: da negozianti a mediatori. Prendono contatti con gli industriali tessili degli stati del Nord, aprono una succursale a New York e in poco tempo l’intermediazione diventa la base della loro attività. La guerra di secessione, con l’abolizione della schiavitù, rende meno fruttuoso il commercio del cotone e i due fratelli Emanuel e Mayer Lehman (Henry, il maggiore, è morto di febbre gialla) scommettono sulla ricostruzione del Sud e con fondi dello stato dell’Alabama creano la loro prima banca, dal cotone passano al caffè e all’investimento nelle ferrovie che proprio nel dopoguerra venivano progettate in tutto il paese. La loro sede è ormai New York, il loro teatro Wall Street.
Il clip dell’allestimento francese di Lehman Trilogy, con la traduzione di Pietro Pizzuti, Chapitres de la Chute, regia di Arnaud Meunier.
La dinastia Lehman attraversa la crisi del ’29 e la Grande Depressione e contribuisce alla ripresa sottoscrivendo quote di capitale per l’industria aeronautica (siamo ormai alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale), dell’industria cinematografica (produrrà fra l’altro King Kong e Via col vento), poi televisiva e petrolifera e negli anni Cinquanta persino di quella informatica, allora agli incunaboli.
Sono ormai in scena le nuove generazioni: Herbert, figlio di Mayer, che sarà governatore di New York e poi senatore democratico; Philip, figlio di Emanuel, e poi il figlio di Philip: Robert detto Bobbie.
Philip è il Lehman analista e decisionista, colui che edificherà l’impero sulle solide basi costruite dal padre e dagli zii. Metodico, attento, “non lascia che niente gli sfugga”: studia sempre a freddo le situazioni e agisce di conseguenza, in tutti i campi, dalla vittoria al giochino di strada delle tre carte alla scelta della moglie alla direzione e all’ampliamento delle attività di famiglia.
Perché Philip
– figlio di Emanuel
nato a New York: nel suo sangue
nemmeno una goccia
né di Germania
né di Alabama –
è una macchina parlante.
Portentosa.
(…)
Governa le parole, Philip,
a vent’anni
sfodera i discorsi come nessuno fa
snocciola domande e si dà – lui stesso – le risposte.
[pp. 107-108]
Il figlio di Philip, Bobbie, che morirà nel ’69, è il rampollo apparentemente più sensibile e più fragile: appassionato di cavalli e di arte ha però il destino già segnato dalla famiglia:
Gli piace disegnare, a Robert.
E se gli chiedono
Cosa farà da grande
Risponde:
“Il pittore!”
Al che sua madre
puntualmente
ben sapendo
che sull’agenda del marito
non è previsto esattamente questo
lo corregge
sorridendo:
“Il banchiere pittore.”
[pp. 170 e 171]
Tant’è.
Robert
Lehman
a chi gli chiede
“Cosa farai da grande?”
risponde:
“Il fantino!”
Al che
sua madre
puntualmente
ben sapendo
che sull’agenda del marito
non è previsto esattamente questo
lo corregge
sorridendo:
“Il banchiere fantino.”
Al che
tuttavia
Philip Lehman
corregge anche lei
in stampatello:
IL FINANZIERE FANTINO.
[pp. 180 e 181]
Bobbie sposa via via tre donne tutte più forti di lui, ha complessi di inferiorità verso il cugino Herbert, che brilla nell’agone politico, quando è emozionato gli tremano le mani e si morde a sangue il labbro… Ma si rivelerà il più cinico e lucido nel pilotare la banca di famiglia attraverso le trasformazioni del capitalismo, da quello ancora tradizionale, legato alla produzione di cose, al capitalismo finanziario, dalla contrattazione delle materie prime all’emissione di titoli farlocchi, dalla finanza produttiva a quella speculativa.
Come dice il Direttore Marketing ai consiglieri di amministrazione, in una scena memorabile che è anche un po’ uno dei fuochi ideologici della saga:
Marketing è
dire a tutti che vinci se compri
se compri trionfi
se compri mi batti
se compri sei il primo.
(…)
Vincere è esistere.
Se faremo entrare in testa
al mondo intero
che comprare è esistere
noi romperemo, signori miei,
quell’ultima vecchia barriera che si chiama:
bisogno.
Il nostro obiettivo
è un pianeta Terra
in cui non si compri più nulla per bisogno
ma si compri per istinto.
[p.297 e ss.]
E poco oltre (ma sono pagine che andrebbero citate per intero):
“but I have a dream
yes
I have a dream”
ed è di vendere prima o poi anche a voi
vendere
vendere
vendere
a tutti quanti
(…)
siamo tutti uguali
perché tutti abbiamo il portafogli
(…)
siamo tutti uguali
perché tutti abbiamo un conto in banca.
“I have a dream
yes
I have a dream”
ed è che tutti i soldi
d’ora innanzi
siano uguali
sotto il sole
e
non solo sotto il sole
perché la NASA ci ha chiesto soldi
per mandare un uomo sulla Luna
“I have a dream
yes
I have a dream”
ed è far soldi
anche lassù.
In questa scena concitata e febbrile non c’è solo il ribaltamento diabolico delle utopie degli anni Sessanta e Settanta (“Rivoluzione non è la soddisfazione dei bisogni ma la stimolazione dei desideri” recitava il maggio francese, intendendo però la liberazione del e dal soggetto) e nemmeno c’è solo il capovolgimento del sogno di Martin Luther King. C’è il delirio del capitalismo finanziario e globalizzato, il punto di svolta anche del destino della famiglia Lehman, che genera la sua futura rovina. C’è il sabba che tuttora stiamo danzando, con la politica ridotta a pura logica economica e il tentativo di cambiare “l’anima e il cuore della gente”, come diceva la Thatcher (bel paradosso per chi si voleva ultraliberale): gli uomini debbono funzionare come un’impresa, diventare imprenditori di sé stessi. La politica ridotta a mera amministrazione del mercato, il popolo al ruolo coatto del consumatore, l’economia a finanza.
La Lehman Trilogy è però un contenitore di molte storie. E col filone principale si intrecciano una quantità di altri temi.
A esempio quello dell’ebraismo, che è fondamentale e a volte sotto traccia a volte in superficie percorre tutto il testo. Innanzi tutto ogni snodo essenziale della vicenda è contrappuntato da citazioni bibliche o dalle Massime dei padri e da altri testi della tradizione ebraica; gli stessi 35 capitoli hanno quasi tutti titoli in yiddish. Ma questa in fondo potrebbe essere una coloritura di superficie. Più interessante notare che la cultura ebraica sostanzia tutta la storia della famiglia Lehman. Sotto questo aspetto Lehman Trilogy ricorda quel grande romanzo che è La famiglia Karnowski di Joshua Singer. Come in quel romanzo, c’è anche qui lo snobismo degli ebrei accculturati e integrati verso quelli di più recente immigrazione; c’è il conflitto fra l’ebraismo riformato e quello originario ashkenazita, più tradizionalista; c’è l’osservanza religiosa che di generazione in generazione si fa più lasca.
Il tempo della famiglia è inizialmente scandito dai funerali dei membri più importanti, con l’osservanza del lutto rituale di una settimana. Ma poi le esigenze del capitale hanno la meglio sulla tradizione. E quando muore Philip:
Direbbe il rito di non uscire per una settimana.
Figurarsi!
Come se l’economia si fermasse ad aspettare.
(…)
Direbbe il rito di non preparare cibo:
chiederlo ai vicini, riceverlo e basta.
Figurarsi!
Come se la servitù fosse in vacanza.
E poi se c’è una cosa giusta
Nel rito dei funerali
È quel buttare la terra dietro le spalle:
i morti ai morti, i vivi ai vivi.
(…)
Direbbe il rito di strappare un abito
Farlo a pezzi appena rientrati
Dopo la sepoltura
Al vecchio cimitero.
Figurarsi!
Sono cose di folklore
o al meglio cose di rabbini
cose che fanno quegli ebrei
venuti in America da poco:
quelli scappati dall’ Europa
dove a essere ebreo ti uccidevano nei campi.”
(…)
Ora che sono di sangue americano, i Lehman
Chi se li ricorda i riti dell’Europa?
Ebrei riformati, ci tengono a dirlo.
Che è come dire: “Facciamo a modo nostro”.
(…)
La sede della banca in One William Street
Oggi nonostante tutto resta aperta.
(…)
Tre minuti di silenzio per tutto il personale.
Niente di più niente di meno:
c’è il mondo intero che ci sta a guardare
l’America è una grande azienda
e Wall Street non può dormire
perché la Terra gira intorno al Sole
e sui mercati non fa mai buio.
[p.269 e ss.]
Sulla particolare struttura drammaturgica del testo rinvio ancora una volta alla prefazione di Ronconi.
Qui vorrei fare ancora solo alcune osservazioni.
I testi di Massini, non solo questo, rientrano in genere in quello che si potrebbe chiamare “teatro civile”, di testimonianza e di impegno. Teatro di parola, quindi.
Ma è un teatro di parola che viene dopo le avanguardie e le neoavanguardie e la postavanguardia, dopo il moltiplicarsi dei modi in cui la scena guarda la realtà, dopo tutto il teatro di ricerca cresciuto ed egemone dagli anni Sessanta, dopo la disarticolazione del linguaggio, dopo il teatro del gesto, dell’urlo, dell’ immagine, dell’azione fisica, dopo il teatro di poesia reinventato da Pasolini. In sintesi, dopo l’esplosione della teatralità in mille forme diverse, dopo tutto quello che è stato genericamente chiamato il Nuovo teatro o, meglio, teatro di sperimentazione o di ricerca e di cui lo scopritore e primo editore di Massini drammaturgo, cioè Franco Quadri, è stato come sempre geniale esegeta, e non solo. Infatti accompagnò questa ripresa della parola fin dalla Biennale Teatro veneziana del 1984, con la casa editrice, con il Premio Riccione e in vari numeri del “Patalogo” di quegli anni, fino al volume 17, del 1994, con l’inserto a più voci L’Italia delle drammaturgie.
Grazie anche a quell’esplosione la parola di oggi non è più quella del teatro borghese né quella del teatro politico militante. È una parola espressiva ma non letteraria: non indugia, non descrive, ma osserva e fa vedere, si mette dalla parte dello spettatore, per così dire. Si inventa la lingua (penso per esempio a Mimmo Borrelli e a tutti quelli che riscoprono creativamente il dialetto o declinandolo musicalmente o lavorando sulla mescidazione e sulla stratificazione, sui cortocircuiti linguistici come fa Enzo Moscato, per restare in area napoletana). Non è mai comunque una parola pulita, ordinata. O sociologicamente intonata, anche quando, come qui, tratta problemi attuali e concretissimi. Una parola che può incarnarsi nel monologo del cosiddetto teatro di narrazione, nel cunto di Davide Enia o nell’affabulazione di Ascanio Celestini o nelle memorie di Marco Paolini e di altri.
In Massini la parola è piuttosto all’incrocio fra narrativa e teatro, un esempio formidabile di quella “drammaturgia difficile” che appunto Ronconi predilige, come dichiara anche nella prefazione.
Lehman Trilogy è scritto quasi sempre in maniera indiretta, come fosse una lunga didascalia, sia pure interrotta da battute, sia polifoniche sia monologiche. È ovvio il richiamo al teatro epico di Brecht. Ma potrebbe anche essere un cantare di quella tradizione toscana che dal Trecento arriva fino a tutto l’Ottocento e che con gli ultimi cantastorie che giravano per i piccoli centri di campagna è proseguita fino a metà del Novecento. Dei cantastorie, dell’ epica e del cantare popolare sono alcuni tratti caratteristici di questo testo, come l’iterazione, gli epiteti ricorrenti, gli attributi; penso a esempio ai soprannomi – la mente, il braccio, la patata – dei tre capostipiti Lehman; o al sempiterno vestito bianco di Bobbie, il nipote di Emanuel).
La scrittura suggerisce sempre gesti e azioni: sono queste che definiscono il personaggio o l’ articolarsi degli eventi.
Solomon Paprinskij, uno dei personaggi che personalmente preferisco, è un equilibrista che ricompare più volte e sempre in momenti cruciali, collegati agli alti e bassi di Wall Street. Incarna cioè l’idea del rischio e della precarietà, ne è la metafora in un certo senso. Ecco come viene presentato:
Solomon si ferma
in piedi
davanti al grande palazzo.
Sceglie due lampioni
A distanza di 50 metri.
Ecco: questi due.
Proprio a un passo
dal portone d’ingresso.
Solomon apre una valigia
tira fuori il suo filo d’acciaio
lo stende
dritto
teso
arrampicandosi
su per i lampioni.
La strada è pronta:
il filo è a posto.
Cosa manca?
Il coraggio.
Solomon Paprinskij se lo dà:
tira fuori una bottiglia
butta giù un bel sorso di cognac
poi
sale su
va in posizione,
Solomon Paprinskij,
e comincia a camminare.
Perfetto.
Aereo.
Leggerissimo.
Non sbaglia un passo,
Solomon Paprinskij:
è il migliore equilibrista
che New York conosca.
[p. 103]
Solomon Paprinskij continuerà i suoi volteggi fino a settant’anni, accompagnando la Borsa fino al crollo del ’29, quando cadrà anche lui slogandosi per sempre una caviglia.
Ma oltre che con gli alti e bassi della Borsa la sua presenza ritma anche la vita di Philip Lehman. E come suo figlio lo sostituirà sulla fune tesa attraverso Wall Street, così il figlio di Philip, Bobbie, prenderà il posto del padre alla guida della banca. E analogie e rimandi interni di questo genere percorrono carsicamente tutto questo testo fluviale.
Ogni momento forte della saga famigliare, gli snodi dell’azione, sono sempre segnati da un evento raccontato in chiave teatrale.
A esempio l’allargarsi della clientela nella piccola attività commerciale degli inizi è raccontato in questo modo:
La piccola stanza
sul viale Montgomery
con la porta che s’incastra la maniglia
e la grande scritta nera e gialla Lehman Brothers
è diventata un andirivieni di gente diversa.
Ora entrano i cappelli di paglia delle piantagioni
ma anche i sigari accesi degli industriali;
i neri come Testatonda Deggoo
e i bianchi commercianti nordisti:
come Teddy Wilkinson
una botte incravattata
barba bionda, sempre sudato.
[p. 30]
Le metonimie di questo passo sembrano già indicazioni per gli interpreti, così come, in un’altra scena, la descrizione di Lew Glucksman, il futuro capo della sezione dei mutui finanziari che porterà poi alla catastrofe:
Questo ragazzo
per esempio
che ora entra nel suo ufficio
con le gote come due meloni
avrà trent’anni, poco più.
Sguardo dritto, perfino troppo
strafottente l’amico
un tipo tosto
grande pancia
si direbbe incazzato
questo spacca il culo al mondo
a colpi d’ascia.
[p. 305]
Così la descrizione della Borsa di New York (pp. 104-107);
la visionaria progettazione della ferrovia ancora inesistente (p. 122); il meccanismo impazzito della finanza reso come un twist frenetico ballato anche da un isterico Bobbie Lehman ottantenne (pp. 316 e ss.).
La progressiva espansione finanziaria della Banca è descritta dai viaggi di Bobbie:
Sul suo Boeing 707
rimbalza Bobbie
come una biglia
da una parte all’altra:
ché il mondo è piccolo
come un tavolo da biliardo
e se oggi gioca a golf con Eisenhower
domani prenderà il suo cocktail
sì, a Singapore.
[p. 288]
E la terza parte si apre con un montaggio cinematografico, straordinario per ritmo, in cui la crisi del giovedì nero si intreccia con la vicenda matrimoniale di Bobbie. Ai suicidi seriali degli agenti di Borsa si alternano le tappe del suo primo matrimonio e a ogni cambio di contesto la parola che chiude un quadro è la stessa con cui si apre il seguente in un rimando sonoro e ritmico (pp. 224-239).
Del resto il ritmo è uno dei pregi di questo testo così eccedente e insieme controllatissimo, in cui si intersecano differenti sequenze temporali: quella lunga della storia e dell’economia, quelle della famiglia Lehman, quelle dei protagonisti principali ma anche di molti personaggi minori. Sequenze tutte orchestrate con uno straordinario senso del tempo, questa volta in senso musicale non cronologico, che si dilata e si stringe, con un andamento sempre più veloce e concitato man mano che si arriva al fatidico 2008. Ma anche con repentini cambi di passo interni.
E queste discronie sono rese da una prosa ritmica che tende a scandirsi subito in verso. In America ne farebbero un musical.
Tag: Luca Ronconi (77), Stefano Massini (10)
1 Commentoa“Il Crepuscolo dei divini indici di Wall Street nell’epopea di Stefano Massini”
Scrivi un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.


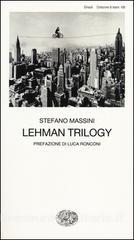







[…] Il Crepuscolo dei divini indici di Wall Street nell’epopea di Stefano Massini […]