La democrazia come arte performativa
David Wiles, Democracy, Theatre & Performance. From the Greeks to Gandhi
Che cosa ha reso possibile la vittoria della Brexit al referendum del 23 giugno 2016 e l’assalto al Campidoglio dei seguaci di Donald Trump del 6 gennaio 2021? Come è possibile che “la gente” voti democraticamente leader bugiardi e incompetenti?
Le ragioni sono numerose, ma per uno storico del teatro come David Wiles un elemento appare evidente: la performance dei loro avversari è stata un fiasco. Sulla scena politica, Johnson e Trump sono stati attori più efficaci dei loro avversari politici.
- Boris Johnson: “Get Brexit Done”
- Nigel Farage: “We Want Our Country Back”
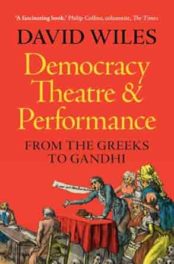 Democracy, Theatre & Performance. From the Greeks to Gandhi (Cambridge University Press, 2024) esplora gli intrecci tra teatro, democrazia e retorica, che nacquero e si svilupparono contemporaneamente ad Atene, tra il VI e il V secolo avanti Cristo. Wiles parte dai limiti e dalle degenerazioni della democrazia, che avevano suscitato la riflessione politica di Platone, quando denunciava la “teatrocrazia” che aveva sostituito l’aristocrazia.
Democracy, Theatre & Performance. From the Greeks to Gandhi (Cambridge University Press, 2024) esplora gli intrecci tra teatro, democrazia e retorica, che nacquero e si svilupparono contemporaneamente ad Atene, tra il VI e il V secolo avanti Cristo. Wiles parte dai limiti e dalle degenerazioni della democrazia, che avevano suscitato la riflessione politica di Platone, quando denunciava la “teatrocrazia” che aveva sostituito l’aristocrazia.
I teatri da muti diventarono vocianti, come se chiunque avesse orecchio per capire ciò che nella musica è bello e ciò che non lo è, e in luogo di un’aristocrazia competente in tale campo si sostituì una cattiva “teatrocrazia”. Se una democrazia formata da uomini liberi si fosse limitata al solo ambito musicale, non sarebbe accaduto nulla di terribile: ma ora, presso di noi, ha preso origine dalla musica l’opinione per cui tutti sanno tutto e un’illegalità che si è accompagnata alla licenza.
Tutti infatti non avevano più paure perché si credevano sapienti, e questa sicurezza ha generato l’impudenza: perché nel non avere timore, a causa della propria insolenza, dell’opinione di chi è migliore consiste la malvagia impudenza che nasce da una libertà eccessiva.
(Platone, Leggi, Libro III)
Teatro e democrazia
Il legame tra teatro e politica, come ingrediente fondamentale della nascita della democrazia, è stato ampiamente esplorato in passato. E’ alla base della filosofia politica di Hannah Arendt in Vita activa (Bompiani, 2019). E’ stata esplorata da storici dell’antichità come Christian Meier in L’arte politica della tragedia greca (Einaudi, 2000) e dagli autori convocati da Simon Goldhill e Robin Osborne, curatori di Performance, Culture and Athenian Democracy (Cambridge University Press, 1999). Di recente, il rapporto conflittuale della filosofia con il teatro (e con la retorica) è stato approfondito da Simon Crichtley (vedi Oliviero Ponte di Pino, A lezione dagli antichi https://www.doppiozero.com/critchley-lezione-dagli-antichi), mentre alcune delle preoccupazioni dei critici della democrazia, in stretta connessione con l’attualità politica, riemergono in La democrazia del signori di Luciano Canfora (Laterza, 2022).
Rispetto ai suoi predecessori, Wiles fa un passo in più. Per gli ateniesi, anche la politica – e soprattutto la democrazia – è spettacolo.
|
. |
|
Alla democrazia nascente, il teatro ha offerto in primo luogo una pedagogia politica. Gli agoni tragici insegnavano ai cittadini la pratica del dibattito pubblico e della deliberazione. Dopo aver visto i tre cicli tragici delle Grandi Dionisie, gli ateniesi sceglievano il migliore, anche se le modalità di voto erano peculiari:
Nell’assemblea si votava alzando la mano destra, perché era necessario massimizzare il consenso, mentre nelle giurie dei tribunali lo scrutinio era segreto per evitare ritorsioni. Gli ateniesi avevano capito che il voto per acclamazione avrebbe ridotto la possibilità per il drammaturgo di insegnare e provocare, e perciò elaborarono un sistema che ricorda quello delle moderne giurie, con un gruppo ristretto di normali cittadini che votano a nome dell’intera comunità. Ad Atene il sistema “italiano” (quello utilizzato nella Magna Grecia siciliana, con il voto palese di tutta la platea, n.d.r.) non poteva funzionare, perché in platea i cittadini sedevano insieme ai non cittadini e alcuni spettatori assistevano agli spettacoli fuori dai limiti dell’auditorium. E si lasciava un certo spazio al caso, o agli dei, perché l’importante era l’impegno competitivo.
(p. 78)
Il teatro, suscitando forti emozioni, offriva una palestra di autoanalisi e consapevolezza.
|
. |
|
Seguire le peripezie degli eroi (e delle eroine) sulla scena tragica, e vedere gli attori dare corpo e voce alle loro emozioni per commuovere il pubblico, avrebbe dovuto aiutare gli spettatori ateniesi a capire come i demagoghi potessero manipolare le loro emozioni personali e collettive.
- Geert Wilders: “We Will Make Netherlands Geat Again”
- Donald Trump e Viktor Orban: “Make Europe Great Again”
|
. |
|
Più che un risultato acquisito una volta per tutte, la democrazia è un processo costante e infinito:
|
. |
|

Giorgia Meloni: “Difendiamo Dio Patria e Famiglia”
La democrazia come genere teatrale
Se la democrazia è un genere delle arti performative, accanto alla tragedia e alla commedia, si contrappone ad altri dispositivi: da un lato il coro, dove non c’è distinzione tra attori e spettatori, e l’agorà, il mercato e la piazza dove tutti parlano con tutti; dall’altro le varie forme di monologo, come quelli del predicatore e del tiranno, anch’essi ben addestrati nell’arte della recitazione e della retorica.
I LINK
Lina Bolzoni, Oratoria e prediche, in Letteratura italiana diretta da Alberto Asor Rosa 3, 1041-1074, Einaudi, 1985-1990.
Bernadette Majorana, Lo pseudo-Segneri e il Teatro celeste: due tracce secentesche, in “Teatro e storia”, IX, n. 16, 1994 (Annali 1), pp. 357-388 (ISSN 0394-6932).
Giovanni Boniolo, Il pulpito e la piazza. Democrazia, deliberazione e scienze della vita, Raffaello Cortina, 2011.
Qual è la caratteristica del dispositivo democratico? Come le tragedia di Eschilo, Sofocle ed Euripide, mette a confronto davanti al pubblico diverse narrazioni e punti di vista.
|
. |
|
Salgono sulla scena politica due o più attori che, con le loro parole (e dunque con le loro argomentazioni razionali e i fatti che dovrebbero sostenerle) ma anche con il loro corpo e la loro voce, cercano di conquistare il favore del pubblico con la loro performance. Gli stili di recitazione diventano determinanti per il successo politico, anche in relazione ai diversi contesti storici e culturali. Quale valore assume il gesto, in società che mortificano la fisicità del corpo? Qual è l’equilibrio più efficace tra gestualità e vocalità? La postura di un attore, con la sua capacità di occupare la scena, è sempre più efficace dell’apparente antiretorica dell’uomo qualunque? Quale deve essere il rapporto la la sfera privata e quella pubblica dell’uomo politico? Sono domande che hanno avuto risposte diverse, anche in base alla capacità degli oratori di coinvolgere il loro pubblico.
Curiosamente per Platone una delle pratiche politicamente più deleterie è quello che oggi definiremmo “multimedialità” o “contaminazione” tra i generi. La degenerazione dello spettacolo è iniziata, secondo il filosofo, quando i poeti, “signori incontrastati delle trasgressioni” hanno iniziato nei loro happening a mescolare
i canti funebri con gli inni, e i peana con i ditirambi [ovvero i canti in onore di Apollo e quelli in onore di Dioniso, n.d.r.], e imitando con la musica della cetra quella del flauto, e confondendo tutto con tutto, pur senza volerlo, dicevano delle menzogne contro la musica a causa della loro ignoranza, e cioè che la musica non ha alcuna norma, e che qualunque persona – buona o cattiva che sia – può giudicarne il valore dal piacere che gli procura.
(Platone, Leggi, 3.700-701)
Una breve storia della democrazia
In alcuni momenti chiave della storia, queste performance politiche hanno permesso di fondare e rifondare la democrazia. Wiles studia e recensisce le discussioni politiche come se fossero performance, a cominciare dal confronto in cui lo stanislavskiano Demostene prevale sul brechtiano Eschine. Ci porta in Inghilterra ai tempi della rivoluzione puritana di Oliver Cromwell, a Parigi ai tempi della Rivoluzione Francese, negli Stati Uniti poco dopo l’indipendenza, nell’India che grazie a Gandhi raggiunge l’indipendenza (mentre Muhammad Ali Jinnah portava alla secessione del Pakistan musulmano).
Se il nesso tra teatro e democrazia è così stretto, la performatività del teatro aspira a tradursi in performatività politica.
|
. |
|
I limiti della democrazia
Wiles è consapevole dei limiti della democrazia, che spesso cade preda di leader bugiardi che conquistano il consenso nonostante le fake news e le evidenti menzogne, e anzi con questi messaggi riescono a intercettare lo stato d’animo profondo e i desideri segreti del popolo.
Sono infiniti gli episodi storici in cui “la folla” (per dirla con Gustave Le Bon) o “la massa” (per dirla con Elias Canetti) viene manipolata e travolta dall’emozione e si affida al tiranno. Anche Shakespeare temeva “the mob”, la sua furia incontrollabile e della sua volubilità. Lo testimonia in Henry VI Part Two il suo racconto della rivolta di Jack Cade, il demagogo animato “dallo spirito di buttar giù re e principi…”. Prima di essere sconfitto e ucciso, il ribelle Cade si chiede retoricamente: “Ci fu mai piuma che si muovesse al vento come questa moltitudine?”
Proprio per la sua natura performativa, la pratica della democrazia agisce su diversi livelli: ragione e sentimento, gestualità e voce, oralità e scrittura, sincerità e mistificazione. I critici della democrazia (della schiera che si muove sulla scia di Platone, Wiles ricorda Hobbes e Rousseau) erano ben consapevoli che
|
. |
|
- Matteo Salvini: “Prima il Nord”
- Matteo Salvini: “Prima l’Italia”
- Matteo Salvini: “Più Italia meno Europa”
- Matteo Salvini: “Difendere i confini non è reato”
- Matteo Salvini; “Free Europe”
La democrazia, come racconta Wiles e come sapevano Platone e Aristotele, può entrare in crisi per dinamiche interne: i demagoghi e i populisti possono essere ottimi attori, che sanno come eccitare e governare le emozioni del pubblico.
A mettere in crisi la democrazia, se la tesi di Wiles è corretta, è anche l’evoluzione della mediasfera e la marginalizzazione del teatro all’interno della società. In primo luogo c’è l’affermazione della stampa, che pone l’accento sulla parola e sull’argomentazione.

Matteo Salvini e Geert Wilders

Geert Wilders; “Nemmeno un centesimo all’Italia”
Ma le nostre scelte (anche quelle elettorali) non sono basate solo su argomentazioni razionali (o sulla base degli interessi personali) ma su sentimenti ed emozioni. A farci cambiare idea non sono tanto i fatti (le news, vere o fake) quanto le emozioni, un cambiamento del quadro valoriale di riferimento, e soprattutto una diversa affiliazione a identità di gruppo o collettive:
|
. |
|
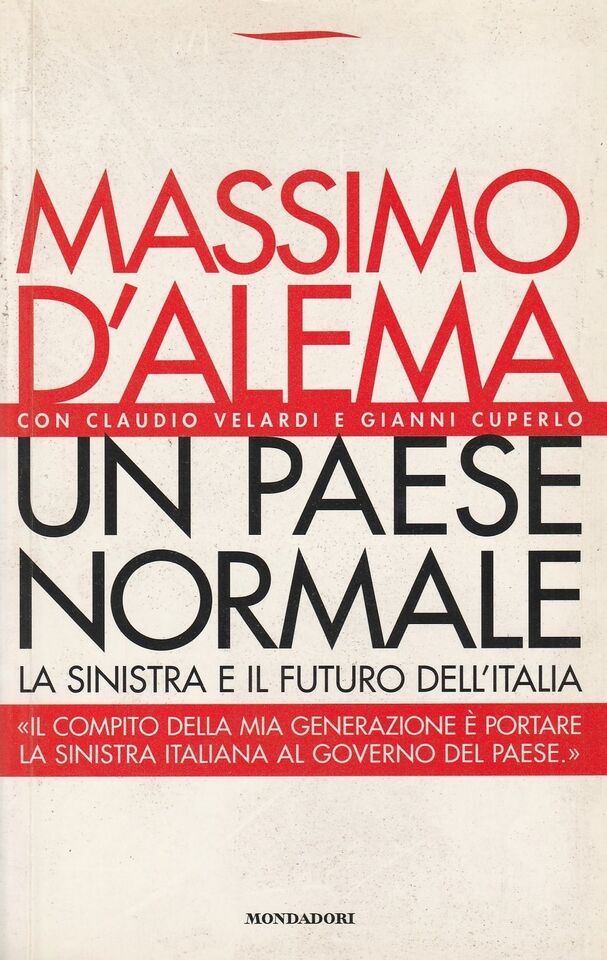
Massimo D’Alema, Un paese normale

Alice Weidel: “Germania. Ma normale”
Un altro elemento discriminante è la “sincerità” degli attori politici, con un paradosso: per ottenere performance efficaci, agli attori si chiede di fingere consapevolmente, mentre agli oratori politici si chiede di essere tutt’uno con il loro personaggio, anche se usano gli stessi strumenti degli attori.

Marine Le Pen: “Ridare ai francesi i loro soldi”, “Ridare ai francesi il loro paese”
Nella visione di Wiles a mettere in questione i fondamenti della democrazia è anche l’uso dello schermo. O meglio, la passività che induce il filtro tecnologico, una trasformazione che peraltro il teatro aveva già stato anticipata. Fino all’Ottocento, durante le rappresentazioni la platea restava illuminata, dando la possibilità di una forte interazione tra il pubblico e quello che accedeva in scena, in quella che poteva essere considerata “una forma di democrazia diretta”. E tuttavia,
|
. |
|

Robert Fico: “Per le persone della Slovacchia”
Cambiare idea, cambiare identità
La democrazia si fonda sulla capacità di persuasione e dunque sulla possibilità di “change your mind”, che non vuol dire soltanto “cambiare idea”, ma “cambiare la mente”, ovvero il quadro di riferimento, a partire dalla consapevolezza che nella vita ogni essere umano copre diversi ruoli. Se il teatro in quanto rappresentazione appare impotente di fronte all’impatto dei mass media, secondo Wiles il suo ruolo resta fondamentale a un altro livello:
|
. |
|
ABSTRACT
The article discusses David Wiles’ work, Democracy, Theatre & Performance, which explores the intrinsic link between democracy and theatrical performance. Wiles analyses how political rhetoric and gestures, similar to theatrical ones, influence popular consensus, citing historical examples from ancient Athens to the modern era. The author highlights how the ability to persuade, manipulated or not, is crucial in democracy, and how the media, unlike theatre, can limit interaction and the formation of a collective feeling. Finally, Wiles stresses the importance of theatrical and rhetorical education for an informed citizenship.












