Lo sguardo insoumis di un rabdomante del teatro
Per Georges Banu (1943-2023)
Insoumis, una delle sue parole predilette.
Da non confondere con il ribelle, insoumis era per Georges l’attore capace di oltrepassare il quadro (scenico, teorico) introducendo dall’interno una faglia che destabilizza l’ordine, aprendo a un altro piano, un altrove che rivela (Les voyages du comedien, Gallimard, 2012).
L’Insoumis è unico, ma non solitario, agisce in relazione.

Georges Banu, Les voyages du comédien (Gallimard, 2012)
In fondo, come tutte le parole da lui accuratamente misurate, era un riflesso di quello che è stato Georges. Insoumis, come quando fugge dalla sua Romania ammutolita dal regime soffocante di Ceausescu, arrivando nel Capodanno del 1973 a Parigi, la città che diventerà il suo doppio. E lo decide una sera, assistendo in un teatro quasi deserto al Sogno di una notte di mezza estate di Peter Brook, bollato dalla censura e condannato dal governo. Nel Puck che scende tra il pubblico per stringergli la mano dicendo “Good Bye”, vede un invito a uscire dal quadro: “Era arrivato senza dubbio il tempo di liberarsi dalla paura e di partire”.
L’esilio è assetato di libertà, politica e mentale, che lo distanzia da approcci sistematici o confortanti, e lo avvicina alla pratica degli artisti, primo tra tutti Peter Brook di cui diventa strettissimo amico. L’urgenza di condividere pensiero e idee (“il teatro è un pensiero orale relazionale che si nutre del legame e del desiderio di comunicare”, diceva) lo porta a insegnare all’università Sorbonne Nouvelle Paris 3, all’Institut d’Etudes Théâtrales di cui diventa presto una colonna portante. I suoi corsi affollati di studenti erano laboratori di discussione concentrata, di generoso scambio di visioni e percezioni. Diverse generazioni di studenti vi si formano a una libertà di sguardo e scrittura, accompagnati da Georges che apriva varchi, appassionati, necessari, insperati.
Lo faceva anche fuori dalle aule, sulla strada, nei caffè, nelle stazioni della metropolitana. Come chi è fuggito, non perdeva mai tempo, Georges, né si sprecava in convenevoli. Andava subito al sodo che individuava rapidamente, smascherando i travestimenti e le finzioni, anche inconsapevoli. Non si faceva attrarre dalle forme, pur essendo un finissimo esteta che si nutriva di bellezza e si circondava di arte.
Sul dorso della sua mano sinistra appuntava velocemente, con il suo pennarello nero, una concisa lista quotidiana di incombenze da liquidare e dimenticare. Lì delegava l’azione e il brusio delle necessità, al resto del corpo la contemplazione, attiva di ogni istante. Curioso, mai distratto, si offriva al suo interlocutore, chiunque fosse. Non conversava, utilizzava le parole come oggetti vitali e unici. E intanto assorbiva i luoghi, gli spazi, scovando i dettagli, i tagli di luce che ricordava dopo anni, quasi condensassero il senso del momento. Scriveva in uno dei suoi ultimi libri, Les récits d’Horatio:

Georges Banu, Les Récits d’Horatio (Actes Sud, 2021)
La verità si dice tra due porte, mi ha detto un giorno Cioran. La parola tra due porte non è rubata, né programmata, si formula in una situazione furtiva, un lampo di luce condiviso. Per questo non ho dimenticato né le parole formulate, né i luoghi da cui mi sono arrivate. La parola e lo spazio, la memoria li conserva insieme.
Parlavamo spesso di teatro camminando speditamente per Parigi. Sospendeva un instante il movimento per pronunciare un aggettivo definitivo, e poi di nuovo a passo affrettato verso uno tra le centinaia di luoghi di produzione artistica che frequentava ogni sera, fosse un teatro nazionale o qualche piccolo seminterrato in periferia. Non c’era scena che non l’avesse visto spettatore. A Parigi. E altrove. In Romania dove tornava spesso, in Polonia, in Grecia, nelle Americhe, in Giappone e non solo. Si muoveva infaticabilmente in una cartografia teatrale del pianeta che includeva centri di ricerca, compagnie, teatri e festival internazionali, con i quali spesso collaborava. Primo tra tutti quello di Avignone al quale propose, più di vent’anni fa, di sostituire le conferenze tra artista e critico con una pratica di critica pubblica e partecipata tra artisti, pensatori e spettatori portatori di posizioni diverse e visioni differenti.

Georges Banu, L’acteur qui ne revient pas (Gallimard, 1993)
A ogni suo passaggio creava legami. Anche in Italia, di cui conosceva bene la scena. Lunga la sua amicizia con Giorgio Strehler: per ricordarlo partecipò, pochi mesi fa, all’omaggio organizzato dal Piccolo Teatro. Il suo cosmopolitismo non era bianco ed eurocentrico. Fu il primo a segnalare l’insoumission radicale dell’attore burkinabé Sotigui Kouyaté nella Tempesta di Brook, destinato a imporsi sulle scene europee come uno dei più sensibili attori della seconda metà del secolo. A lui era legatissimo, e si avvicinò alla ricca rete di artisti africani che frequentavano Kouyaté. Senza scomodare alcun esotismo, né letture antropologiche, che in quegli anni si sprecavano. Strettissima anche la sua amicizia con l’attore giapponese Yoshi Oida e frequenti i suoi viaggi in Giappone, alla cui scena dedicò il libro L’acteur qui ne revient pas (Gallimard, 1993).
Per Georges, la critica non poteva essere disgiunta dalla relazione umana con l’artista. Credeva e si predisponeva al caso di cui accoglieva le coincidenze come epifanie da non trascurare. Con un certo sesto senso antico, si dirigeva sicuro verso un’intuizione che spesso era anche un incontro. Stringeva legami profondi e stabili, primo tra tutti quello con Monique Borie, compagna nella vita e alleata nel lavoro, in un’indipendenza e un’autonomia teorica rara e preziosa.
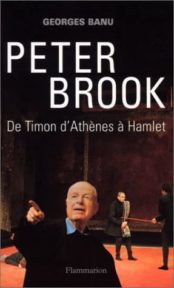
Gerges Banu, Peter Brook. De Timon d’Athènes à Hamlet (Flammarion, 2001)
Fu amico fraterno e confidente discreto di alcuni dei più influenti artisti della scena. Da Antoine Vitez, che gli affida la creazione della rivista “L’Art de Théâtre” per il teatro di Chaillot. A Peter Brook, con cui intreccia un movimento reciproco di creazione-critica che nutre entrambi e che permette a Georges, unico, di tradurre in teoria interpretativa l’imprendile e mobilissima essenza del regista inglese (citiamo solo Peter Brook. De Timon d’Athènes à Hamlet, Flammarion, 2001). Insieme danno vita ad alcune pubblicazioni comuni (Avec Shakespeare. 2016, Avec Grotowski, 2018, Tempest Project, 2020, tutti per Actes Sud). Anche con Jerzy Grotowski scriveva, passando con lui estenuanti notti a tradurne i testi in francese. E poi Ariane Mnouchkine, Tadeusz Kantor, Peter Stein, Bob Wilson, Eugenio Barba, Krzysztof Warlikowski, Pippo Delbono, Patrice Chéreau, Andrei Serban, Thomas Ostermeier.
Con loro dialogò per anni, non solo e non tanto nei teatri, ma nella quotidianità. “Senza farne dei riferimenti esclusivi”. come diceva.
La mia vita è formata dalla comunità di artisti con cui ho fatto il viaggio, costruito sul principio di un fervente e disordinato amore.
E a loro è dedicato il suo recente Les recits d’Horatio (Actes Sud, 2021), di cui stavamo preparando insieme la traduzione italiana. Les recits traccia, per ognuno di questi artisti, un ritratto composto di frammenti di memoria e dettagli sensoriali, catturati istantaneamente dal corpo di un testimone assiduo e abitato, Georges, tale un Orazio passeggero “che si cancella per non dimenticare nulla”. Un lascito teatrale che riflette sull’impermanenza, sul dilemma del “bruciare o conservare”, sulla testimonianza come atto emotivo e soggettivo.

Georges banu, Memorie del teatro (Il Nuovo Melangolo, 2005)
D’altra parte, il ruolo della memoria nella percezione e nella documentazione del teatro ha attraversato tutta l’opera di Georges, legittimando una memoria affettiva ma non emotiva, biografica ma mai personale (Memorie del teatro, Il Nuovo Melangolo, 2005, Miniatures théoriques: Repères pour un paysage théâtral, Actes Sud, 2009, L’Oubli, essaie en miettes, Solitaires Intempestifs, 2002, sul “doppio sotterraneo della memoria, l’oblio, suo alleato soggettivo”).
Pur in ombra, spazio che frequentava con agio, Georges smascherava l’illusione dell’oggettività o della definizione. E di “metodi che confortano ma poco propizi alla relazione con l’arte del teatro”. Che trattasse della scena contemporanea o di forme storiche, le sue pagine sapevano catturare il rapporto interlocutorio tra l’immagine scenica e lo sguardo dello spettatore. E la sua posizione. La scene surveillée (Actes Sud, 2006) va oltre, affrontando il doppio oppositivo vegliare-sorvegliare.
Inquieta e poliziesca, la sorveglianza si esercita da una posizione gerarchicamente superiore ma sotterranea, dissimulata, perversa.
Anche questa volta, il pensiero si palesa una sera a teatro, quando “per un determinato gioco di diagonali, mi ritrovavo, come spettatore, dal lato dei sorveglianti, mentre nella mia vita avevo passato lunghi anni dalla parte dei sorvegliati”. Un rivolgimento che riflette sulle ambiguità del testimone. E la reciprocità troncata e tradita.
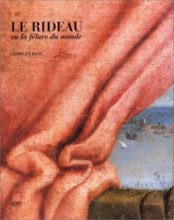
Geroges Banu, Le rideau ou La fêlure du monde (Adam Biro, 1997)
Il gioco sottile dell’osservazione è un’arte che Georges praticava quotidianamente. Alternava uno sguardo preciso al dettaglio a uno lontano d’insieme, come si fa con le grandi tele. Non a caso amava l’arte di Christian Boltanski e di Anselm Kiefer, che impongono sguardi multipli e insinuati e obbligano alla distanza. O la dinamica in movimento di William Kentridge. E i pittori rinascimentali della penombra, che obbligano l’occhio a scavare, e quelli romantici del buio “che spinge a tollerare le incertezze e i dubbi” (Nocturnes: Peindre la nuit, Jouer dans le noir, Biro & Cohen, 2005). Al dialogo tra pittura e teatro aveva dedicato anche Le rideau ou La fêlure du monde (Adam Biro, 1997) e L’Homme de dos. Peinture, théâtre (Adam Biro. 2000).
Era attratto dalla bellezza ferita, segnata dal tempo, incompiuta e imperfetta, brute. Viveva circondato da antichi oggetti che aveva raccolto durante i suoi viaggi, icone sbiadite, statuette buddhiste sbrecciate, marionette giapponesi disarticolate. Ai suoi oggetti feriti aveva dedicato il suo ultimo libro, Les Objets blessés (Cohen&Cohen, 2022). La stanza della sua scrittura era vegliata da antichi Cristi in croce lignei, collezionati laicamente. Il segno lavorato artigianalmente del dolore e della morte. E insieme, per uno dei suoi tipici slittamenti dissacranti, il ricordo del corpo di Cieslak nel Principe Costante. Consapevole del tempo, Georges nominava spesso la morte, tra una cosa e l’altra, infilata lì. Era un fatto, l’impermanenza della vita, il suo durare un soffio. A partire da questo misurava la giornata, gli incontri, le parole, sfrondando l’inutile.

Georges Banu, Les Objets blessés (Cohen&Cohen, 2022)
Georges era un instancabile rabdomante della vita che riconosceva nitidamente nelle sue manifestazioni artistiche. L’oggetto da lui osservato diventava il ricettacolo del mondo. E i suoi libri ne sono una testimonianza. La sua scrittura sciolta, spettinata, vitale, porta il peso e la grana della materia che ha incontrato. Prolifico (circa 50 opere in diverse lingue), ma conciso ed essenziale, procedeva per brevi paragrafi autonomi e progressivi. Insofferente alle note, tanto da obbligare le case editrici a sbarazzarsene, si appoggiava su accostamenti e corrispondenze, polifonie sensoriali e svelti frammenti, offrendo al lettore tracce e non mappe, lenti e non prospettive. La sua lingua, ostinatamente inadatta alla saggistica, ha introdotto una faglia, insoumise, nella critica aprendola ad altre possibilità, soprattutto in Francia.
Eppure non è nella vasta produzione scritta che si trova la sua eredità (in arrivo anche un saggio postumo per Deuxième époque). Da bravo artigiano della parola, Georges conosceva gli incoercibili limiti della scrittura, rigida e incurvabile, incapace di registrare l’istante abitato. Perciò insisteva in una pratica di conoscenza multiforme e flessibile, fatta di incontri e rapporti umani, pronta ad accogliere il passaggio del pensiero che si crea nel dialogo. Lo sanno i moltissimi che lo frequentavano, registi, drammaturghi, studenti, critici, artisti e curatori, dagli ambienti più disparati e apparentemente inconciliabili, riuniti nella sua rubrica telefonica che era una rete di connessioni, affinità e collaborazioni, sempre nuove. “Sono stato un buon agente di legami”, diceva ridendo.
Prima di andarsene veloce, si voltava fermo e salutava con una parola a lui cara, “Courage”. Tra le due porte.

Georges e Tintoretto, Venezia, Maggio 2022 (foto Rosaria Ruffini)
Tag: BanuGeorges (3), critica teatrale (85), memoria (2)





