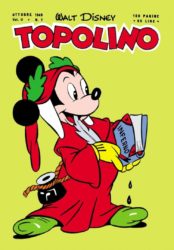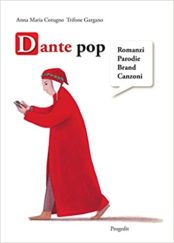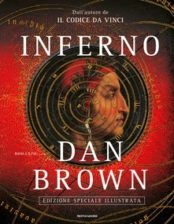#Dantedì | Dante e Bice
La Divina Commedia come non l'avete mai immaginata
 Guelfi e ghibellini… quando avevo cominciato a studiare Dante, ero molto orgoglioso di un trucco per memorizzare il significato delle due parole: “guelfi”, bisillabo, si lega a quell’altro bisillabo, “papa”, mentre il quadrisillabo “ghibellini” si sposa con le cinque sillabe di “imperatore”. Dante, bisillabo, senz’ombra di dubbio era un guelfo; ma perché Foscolo nei Sepolcri (allora, nel 1945, i Sepolcri li studiavamo a memoria) lo chiama “il Ghibellin fuggiasco”? Già, ci sono i guelfi bianchi e quelli neri, e si combattono ferocemente, e Dante è un bianco, e la sua “parte” è perdente, e chi perde non va all’opposizione, ma viene bandito, se non più semplicemente giustiziato. E i bianchi, forse, sono più vicini ai ghibellini…
Guelfi e ghibellini… quando avevo cominciato a studiare Dante, ero molto orgoglioso di un trucco per memorizzare il significato delle due parole: “guelfi”, bisillabo, si lega a quell’altro bisillabo, “papa”, mentre il quadrisillabo “ghibellini” si sposa con le cinque sillabe di “imperatore”. Dante, bisillabo, senz’ombra di dubbio era un guelfo; ma perché Foscolo nei Sepolcri (allora, nel 1945, i Sepolcri li studiavamo a memoria) lo chiama “il Ghibellin fuggiasco”? Già, ci sono i guelfi bianchi e quelli neri, e si combattono ferocemente, e Dante è un bianco, e la sua “parte” è perdente, e chi perde non va all’opposizione, ma viene bandito, se non più semplicemente giustiziato. E i bianchi, forse, sono più vicini ai ghibellini…

Il diavoletto Geppo e Dante disegnati da Sandro Dossi
Come fare a ricordare tutto questo, e soprattutto a capirlo? C’era una formidabile scorciatoia, inventata un secolo prima, e bastava cercarla. Si trova tutta in un aureo libretto – “libretto” non sta per libro di piccole dimensioni, ma per opuscolo nel quale viene stampato il testo di un melodramma – il libretto del “melodramma storico-fantastico” Dante e Bice, andato in scena al Teatro Carcano di Milano il 24 agosto 1852.
La musica, composta da Paolo Carrer, un greco milanesizzato, è andata perduta, ma il libretto è facilmente rintracciabile, e ci spiega molte cose, e soprattutto perché Dante viene cacciato da Firenze: è un uomo tracotante e audace, ed è meglio non averlo tra i piedi. E allora per prima cosa gli s’impedisce di sposare Beatrice, anzi Bice: “spente a lui pria le tede” (le tede, per chi non se lo ricordasse, sono le fiaccole che accompagnano la sposa nella nuova casa del marito); “poscia ostracismo avrà”. D’altra parte, come pretendere che un coro di Nobili Fiorentini si metta a discutere di guelfi e ghibellini?
- Topolino come Dante
- Walt Disney, L’Inferno di Topolino, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1971. Conte Ugolino Canto XXXIII
- Paper Dante
I due innamorati, naturalmente, ignorano di essere così poco amati dai concittadini, e li vediamo affacciati a un verone da cui si scorge il Lungarno parlare dolcemente d’amore: è un duetto fra soprano (Bice) e tenore (Dante), che inizia
“Quai colombe, che il disio / dolce al nido abbia chiamate, / colle ferme ed apert’ali, / pel voler vi son portate, / sì l’un’alma all’altra intese / nel vederci, e in noi s’apprese / l’alto amor, ch’a ogni pensiero / siede primo e regna in me”.
 Loro naturalmente non sanno di parlare d’amore usando le parole di Francesca che, per noi, sono un segnale di sventura. E infatti sopraggiunge Folco, il padre di Bice. Dante si accorge subito che qualcosa non va per il giusto verso (“spira su noi procella / di sventura e dolor”): il matrimonio non si farà. Stupore di Dante – “oggi guidar dovevine / d’amore al santo altar” – e incredulità di Bice – “oh no, non so comprendere / ciò ch’ora ascolto, o padre” – ma esiste una flebile speranza, che Folco, sommessamente, confida a Dante: “al Senato in mano / rendi il poter sovrano… / Figlia, dovizie, onori, / io tutto a te darò…”.
Loro naturalmente non sanno di parlare d’amore usando le parole di Francesca che, per noi, sono un segnale di sventura. E infatti sopraggiunge Folco, il padre di Bice. Dante si accorge subito che qualcosa non va per il giusto verso (“spira su noi procella / di sventura e dolor”): il matrimonio non si farà. Stupore di Dante – “oggi guidar dovevine / d’amore al santo altar” – e incredulità di Bice – “oh no, non so comprendere / ciò ch’ora ascolto, o padre” – ma esiste una flebile speranza, che Folco, sommessamente, confida a Dante: “al Senato in mano / rendi il poter sovrano… / Figlia, dovizie, onori, / io tutto a te darò…”.
Neanche morto, risponde Dante.
E nel secondo atto, che si svolge nella Gran sala dei Cinquecento, dovremmo capire qualcosa di più… ma tutto si riduce a una contesa di potere fra Dante e il podestà Gabrielli che accusa Dante di tradimento, e lo condanna al rogo. Per fortuna interviene Folco e il rogo viene mutato in esilio:
“vita errante e dolorosa / s’abbia Dante; in bando andrà: / così, fama sanguinosa / risparmiata a noi verrà”.
Bice sviene, e Dante viene trascinato via.
I primi due atti sono la “parte Storica”; ora, nel terzo atto, entriamo nella “parte Fantastica”. Dante è seduto in un luogo remoto e selvaggio, e medita. Ha già in mente di scrivere una Commedia, e anzi, ne sta già creando qualche verso con la precisa intenzione di vendicarsi di chi lo mandò in esilio e gli tolse la donna amata:
“Chi dannommi a ingiusta pena, / fra tormenti, e tormentati, / fra gli strazii più spietati / dell’inferno, io chiuderò”.
Sappiamo bene che l’ira può ispirare la più alata poesia, ma come riuscire a inventare gli “strazii più spietati”? Per fortuna sopraggiunge Virgilio, e potremmo aspettarci una rappresentazione, sia pure sommaria, delle più raccapriccianti vendette destinate ai fiorentini traditori. Ma come si fa, in un teatro dell’Ottocento, a dar vita agli strazi cui sono destinate le anime dannate? E Virgilio, per così dire, passa oltre, e conduce direttamente Dante alla vista di Beatrice. Prima, però, bisogna attraversare il Tempio della Gloria, dove tutti i grandi poeti del passato s’inchinano a Dante: ma allora la Commedia era già stata scritta? Evidentemente sì: “la gloria t’ha schiusa l’eterna sua stanza, / la vita immortale, col nome, ti fa”. Ed ecco Bice, divenuta Beatrice: “Guardami ben… ben son, ben son Beatrice”, che subito promette: “Presto, o amico, a Bice in seno / chiameratti il gran Fattor”. E con la gradita speranza di una rapida morte, l’opera si chiude.

Dante secondo Maurizio Toninelli
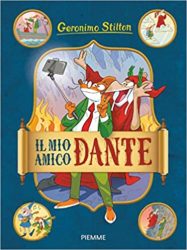 Non ebbe successo, forse a causa della musica non all’altezza della divina impresa, e il compositore se ne tornò nella natìa Zante.
Non ebbe successo, forse a causa della musica non all’altezza della divina impresa, e il compositore se ne tornò nella natìa Zante.
In quanto all’autore dei versi, si chiamava Serafino Torelli, e sapeva leggere nel futuro.
Infatti nel libretto del 1852 si definiva “Professore di Storia Universale e Declamazione all’I. R. Conservatorio di Musica di Milano”, un incarico che ottenne solo nel 1862, e fino al 1870. Per la cronaca, nel corso del Novecento quella materia si chiamava “Letteratura poetica e drammatica”, e nel Duemila è diventata “Poesia per musica e drammaturgia musicale”. Il solito vizio di cambiar nome ai corsi di studio, lasciandoli identici.