Il teatro è solo bianco? Le imperfette identità nel teatro di Ayad Akhtar
Disgraced il dramma vincitore del Premio Pulitzer per il teatro 2013
Il Premio Pulitzer lo conosciamo tutti. L’edizione 2014 è stata vinta dal Cardellino di Donna Tartt per la letteratura e dal “Guardian” e dal “Washington Post” per il lavoro sul Datagate. Era scritto su tutti i giornali e su tutti i siti di informazione. Clap, Clap e tutti contenti.
Ma il Pulitzer non è solo un premio di Letteratura o giornalismo. C’è anche il teatro. Molti purtroppo in Italia non lo sanno e da noi i vincitori del Best Drama non vengono a volte nemmeno segnalati. L’anno scorso ha vinto The Flick di Annie Baker. L’edizione 2013 invece ha incoronato uno dei drammaturghi più interessanti del panorama americano degli ultimi anni, Ayad Akhtar, che si è aggiudicato l’ambito premio con la pièce Disgraced.
Nato a New York nel 1970, ma cresciuto a Milwaukee, Ayad Akhtar si è formato in una famiglia pakistana, musulmana, colta (i genitori erano entrambi dottori) e di vedute liberali. A vederlo, Ayad Akhtar sembra la versione buona del tenente Kojak, nemmeno un capello in testa e un’espressione bella vispa stampata in faccia. Gli occhiali che indossa hanno però l’apparenza da nerd navigato: spessi, ampi e con un certo gusto retrò anni Settanta che non guasta. Il sorriso è franco, la fronte spaziosa. Ha una bella parlantina veloce e ogni suo sospiro tradisce una immensa voglia di raccontare storie.
L’amore per la scrittura è nato prestissimo. Quando aveva quindici anni una professoressa, accortasi del suo talento tellurico, lo ha letteralmente “bloccato” nel suo ufficio a scrivere. Due ore di scrittura (e lettura) al giorno e un viaggio attraverso alcuni totem della letteratura europea.
Da Kafka a Musil, da Camus a Rilke, il giovanissimo Akhtar divora tutto. Ma il talento, che la professoressa della sua scuola ha intuito, ci metterà più di quindici anni prima di uscire allo scoperto. In questo lungo periodo Akhtar fa come tutti noi: sbaglia. Balbetta la vita meglio che può. Fa un corso con Grotowski in Italia, si laurea alla Browne Univeristy, fa un paio di film senza importanza e insiste in una scrittura dallo stile mitteleuropeo che non gli appartiene. Insomma, prova a diventare Kafka… e fallisce.
Le cose cominciano a cambiare quando molla Kafka (e anche Rilke, Camus, Musil, a cui però deve tanto) e si dedica anima e corpo a quello che sa raccontare meglio: il suo mondo, ovvero l’esperienza di essere allo stesso tempo pakistano e americano.
Dopo questa folgorazione diventa prolifico e la gente comincia ad accorgersi di lui. Arrivano tre pièce teatrali e un romanzo, American Dervish (tradotto in Italia con un titolo decisamente sdolcinato: La donna che mi insegnò il respiro). Ma sarà Disgraced, la sua pièce per ora più nota, a garantirli il successo.
Disgraced mette in scena l’America e i suoi deliri post 11 Settembre. La domanda da cui parte Akhtar è in fondo semplice e inquietante: quel razzismo istituzionalizzato post 9/11 cosa ha prodotto nei corpi di chi si è sentito colpito da quelle odiose discriminazioni?
La risposta Akhtar la dà costruendo il personaggio di Amir, un avvocato di grido che però vive in modo contraddittorio le sue varie identità. Da una parte c’è l’Asia delle origini, dall’altra gli Stati Uniti che ha conosciuto fin da bambino. Poi c’è l’Islam, che sembra di fatto in aperta lotta con il suo ideale laico del quotidiano. L’identità di Amir è costruita su opposizioni binarie che sembrano a prima vista inconciliabili. Per lui, all’inizio, contano la carriera e l’apparenza. La sua origine certo gli si vede stampata in faccia, ma lui non la ostenta. L’Islam viene negato in ogni suo atto e nascosto ai suoi datori di lavoro. Ma a causa dell’Islam che la moglie, una pittrice newyorchese di successo, lo ha sposato. E’ affascinata dal mondo che coglie nella bellezza del segno grafico delle miniature che adora.
Il dramma personale di Amir (che si trasforma presto in dramma di coppia) si scatena quasi senza preavviso durante una cena dove una coppia di amici – un’afroamericana e il marito ebreo – con i loro commenti e le loro domande fanno emergere il dissidio interiore del protagonista. Un altro personaggio chiave della piéce è Abe, il giovane cugino, che chiede ad Amir di intercedere in tribunale per un iman accusato di terrorismo. E così Amir comincia a nuotare malamente in un dissidio che a tratti nemmeno capisce. Il suo dramma sfocerà nella violenza, travolgendo tutto quello che aveva ottenuto in anni di sacrifici.
Ayad Akhtar gioca sul filo dello stigma che ha colpito i musulmani d’America dopo l’11 settembre 2001. Materiale incandescente, che usa con la sapienza di un vecchio demagogo delle scene. Nessuna sbavatura nelle battute e un ritmo che prende il pubblico alla gola. Al Lincoln Center di NY la sua pièce ha registrato subito il tutto esaurito. Spesso fuori dal teatro la gente si fermava a lungo per parlare degli stessi dilemmi che poco prima erano al centro della scena. Così il palcoscenico americano con Akhtar si è trasformato di fatto in una grande agorà pubblica, nel centro del dibattito.
- Disgraced
- Disgraced
Quello di Akhtar è un teatro che si è molto nutrito di letteratura, ma anche di tanto cinema, da Fassbinder alla Nouvelle Vague passando per il Neorealismo italiano di De Sica e di Rossellini. Ma il suo sguardo acuto riattiva vecchi codici e riattivandoli li rinnova. Nei suoi lavori l’american dream si scontra con la durezza di un presente fatto di discriminazioni, paure e vigliaccheria.
Intorno a quel tavolo – dove Islam, ebraismo, questione nera, supremazia bianca si incontrano e si scontrano – nasce un nuovo paese, un’America di cui a stento riconosciamo il volto e in cui è ancora molto difficile specchiarsi.
Tag: Il teatro è solo bianco? (46)





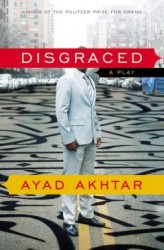
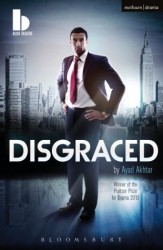







Scrivi un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.