Grotowski in bianco e nero
Intervista a Maurizio Buscarino
Sarà a Milano e Torino nei prossimi giorni Ludwik Flaszen, uno dei più importanti intellettuali polacchi contempotranei, a lungo collaboratore di Jerzy Grotowski. Per iniziativa di Regula contra Regulam, Presenterà il suo libro, Grotowski & Company curato da Fraco Perrelli per le Edizioni di Pagina. Nell’occasione, pubblichiamo l’intervista a Maurizio Buscarino di Massimo Marino, pubblicata su “Hystrio”, anno XXII, n. 1, Milano 2009. Grazie a Maurizio Buscarino, Massimo Marino e “Hystrio”.
Un viaggio nell’“aura” di Grotowski attraverso l’obiettivo di un grande fotografo di teatro, Maurizio Buscarino, che di recente ha recuperato dal suo archivio gli scatti realizzati per le ultime recite di Apocalypsis cum figuris e altre immagini per la mostra in corso a Wroclaw in occasione del decennale della morte.
Ha fotografato il teatro e i teatri, il teatro in carcere, il teatro dei pupi, pellegrinaggi teatrali, spettacoli del teatro di gruppo e le creazioni di Kantor. Maurizio Buscarino è da più di trent’anni l’occhio e la memoria del nuovo teatro. Le sue fotografie non documentano: raccontano, evocano, suggeriscono, interpretano. Tra gli altri ha fotografato anche Grotowski. In particolare le ultime repliche di Apocalypsis cum figuris, nel 1979 a palazzo Reale a Milano, quando ormai era stato annunciato lo scioglimento del Teatr Laboratorium.
HYSTRIO – Da dove parte il percorso che l’ha portata a Grotowski?
MAURIZIO BUSCARINO – Nel teatro sono capitato per caso, nella mia città, Bergamo, al Teatro Tascabile. Qualcuno mi ha trascinato una domenica in quella cantina e lì ho visto Min Fars Hus dell’Odin Teatret. Avevo accettato di entrare perché mi avevano tradotto quel titolo in La casa di mio padre e – mi dicevano – aveva qualcosa a che fare con Dostoevskij. Fui profondamente colpito – forse per la mia verginità teatrale – da uno sguardo di Else Marie Laukvik. Per alcuni giorni ho continuato a ripensare a quella “cosa” stranissima che avevo visto. Ho scritto qualche pagina, volevo consegnargliela. Ma erano già partiti. Però lì ho conosciuto i ragazzi del Tascabile e ho preso a seguire il loro lavoro. Mi tolleravano appena. Erano una setta. Li osservavo e loro sapevano di essere osservati. Così è iniziato il mio percorso di spettatore imperfetto e ho cominciato a sapere di Grotowski.
HY – Da dove nacque il servizio su Apocalypsis?
M.B. – Servizio? Non servivano proprio a niente quelle fotografie. Negli anni precedenti avevo cercato altre volte di fotografare il lavoro di Grotowski, ma mi era sempre stato impedito. Tutti parlavano del regista polacco come di un punto di riferimento fondamentale, ma dalle spiegazioni e dai racconti non mi era chiaro perché. Erano per me anni in cui, dopo il disordine degli studi, dopo l’impegno politico, avvolto da un pesante senso della mancanza di una via d’uscita, avevo deviato verso un piccolo segreto, legato a una fotografia, della mia vita: sapere che chi entrava nel campo del mio sguardo sarebbe andato via. Con quella mia fotografia incontrai il teatro. Grotowski mi appariva allora come uno dei punti sui quali si formavano le coordinate di un paesaggio della massima diversità, della estraneità e, soprattutto, della più perfetta inutilità. Rappresentava per me il paradosso dell’essere umano che si mette a giocare, che invera la vita nel giocare a vivere.
HY – Cosa la attraeva di Grotowski?
M.B. – La povertà. Mi affascinava il concetto di teatro povero. Volevo vedere. E quindi ho provato in varie occasioni. Per esempio alla Biennale di Venezia del 1975. Era all’isola di San Giacomo. C’era un temporale, avevo affittato una barchetta perché ero arrivato tardi all’appuntamento del battello che portava gli spettatori al luogo dello spettacolo. C’erano acqua e onde dappertutto, tenevo le macchine sollevate per non bagnarle… Sono arrivato col buio e prima di entrare nel fabbricato dove si faceva lo spettacolo mi hanno gentilmente obbligato a lasciare le macchine fotografiche. E mi hanno dato una mela con cui ho convissuto tutta la notte. Lì ho visto Apocalypsis, arrabbiato, affamato, infreddolito e col povero occhio di vetro tappato. Ecco, l’estraneità diventava anche fisica. Ma, in fondo, guardavo con grande interesse, premeditavo un nuovo appostamento, per legittimare quello che volevo fare, delle fotografie, punti fermi di un “movimento” che aveva dentro di sé la sua stessa fine.
HY – Come è arrivato a fotografare Apocalypsis?
M.B. – È passato qualche anno. Un giorno mi hanno chiamato dal Crt chiedendomi se volevo documentare le ultime repliche dello spettacolo. Con il Teatr Laboratorium non avevo contatti. Però erano stati loro a chiedere di me. Dovevo riprendere alcuni brani dello spettacolo durante una prova, fatta sostanzialmente per me. Quando sono arrivato, Cynkutis mi ha spiegato che dovevo rimanere fermo, seduto in un angolo, senza chiedere nulla, senza dire nulla e senza muovermi. Racconto tutto questo per accennare all’aura fredda che per me circondava Grotowski. Che mi intimoriva, mi separava, ma anche mi proteggeva nel mio punto di osservazione.
HY – E come è andata?
M.B. – In quei giorni avevo letto di un obiettivo non ancora in commercio, con una luminosità quasi pari a quella dell’occhio umano, progettato e costruito dalla Canon per riprendere una scena – poi diventata famosa – illuminata solo dalle candele nel Barry Lyndon di Kubrik. In cambio di alcune fotografie, ne ottenni uno, che mi diede una piccola possibilità in più. Tutto si svolgeva nella semioscurità, ancora maggiore di come la ricordavo, tranne all’inizio quando i due proiettori antidiluviani erano accesi e puntati a bassa intensità contro una colonna bianca. Riflettevano una luce bassa e mediocre sulla sala, sembrava un acquario spento… Poi si procedeva con l’illuminazione di candele, bellissime, gialle di vera cera, ma candele. Dalla camera oscura, di notte, ho tirato fuori qualche brandello di immagine; il giorno dopo sono tornato con alcune stampe. Ricordo un’attesa, viene Cynkutis, le prende con un fare freddo e burocratico che mi ricordava quello dei funzionari del partito di Pomerania, le guarda, mi chiede di aspettare e le porta in un’altra stanza dove c’erano gli altri del gruppo.
HY – Con Grotowski quindi non aveva parlato?
M.B. – No, l’ho soltanto intravisto seduto in un angolo nell’ombra. È presente in un paio di immagini, ma è molto scuro. Insomma li ho sentiti parlare dall’altra stanza e come spesso succede con una lingua straniera e ostica mi sembrava che imprecassero. Poi è tornato Cynkutis per dirmi: «Il signor Grotowski guardando queste fotografie ha capito che lei è uno di noi. Se vuole, questa sera potrà fotografare lo spettacolo con il pubblico, muovendosi liberamente nella scena». Puoi immaginare… Ma questa nuova libertà mi preoccupava ancora di più. Non ne ho approfittato: mi sono mosso molto cautamente dietro il pubblico, forse mi sono inoltrato in scena in un solo momento. Ora dovevo tenere conto anche del pubblico seduto in terra tutto intorno, che non era consapevole della mia “appartenenza”. In realtà mi sentivo più sicuro nella mia illegittimità e anche nella mia estraneità, davanti a qualcosa che non ero sicuro di capire.
HY – In che senso?
M.B. – Continuavo a non percepire una razionalità discorsiva o narrativa, non vedevo, per esempio, l’Apocalisse che mi aspettavo, quella di San Giovanni, se non in una sorta di grande disperazione da ultimo giorno di Cieslak, agita e vissuta nel suo corpo, come un “martire”. Sentivo il ritmo del procedere delle figure verso un silenzio finale, come un forestiero, un visitatore o, se vogliamo, un antropologo, che osserva un agire diverso, di un’altra cultura: non capisce, può solo descrivere ma ne viene affascinato. Ecco, questo era per me Apocalypsis e in generale il teatro, qualcosa al di là della semplice comprensione. In fondo è quello che accade guardando, dalla finestra, chi viene, per compiere il percorso e scomparire dall’altra parte. È nel “campo” dello sguardo che nasce il teatro.
HY – Ha fotografato, in seguito, anche altre fasi del lavoro di Grotowski?
M.B. – No, le liste erano sempre chiuse e governate dal “Comitato” secondo proprie opportunità e disegni. In più pensavo che attraversare il Bosco di notte, da iscritto a una lista di dilettanti, sarebbe stata per me una esperienza un po’ riduttiva rispetto alla mia pratica del bosco, assolutamente solitaria, che ho esercitato fin da ragazzo. Ho fatto delle fotografie sul set di Olmi per Apocalypsis, ho fotografato degli intensi laboratori di Cieslak a Pontedera, una Medea di Elisabeth Albahaca con la regia di Marconcini e Billi, a Buti, in un bellissimo casino di caccia mediceo; poi il gruppo de L’avventura diretto da Pluchinotta a Volterra nel Conservatorio, da cui sarebbe venuto fuori Punzo per attraversare la strada ed entrare nel portone di fronte, quello del carcere. Ho fotografato diversi gruppi qua e là per l’Italia, che si ispiravano all’ipotetico Metodo…
HY – E sulle fotografie fatte a Cieslak, cosa può dirci?
M.B. – Provavo un affetto per Cieslak. Si vedeva in lui il tocco di un demone, un bisogno assoluto di fare teatro e la disperazione di non riuscire a compierlo, specie dopo la chiusura del Teatr Laboratorium. Credo si sentisse perduto. Sapeva di non essere un attore possibile per altri teatri. L’unico a dargli una vera possibilità è stato Peter Brook. L’ho visto l’ultima volta, cieco e ascetico, nel Mahabharata, a cui ho fatto delle fotografie. Sono andato nel camerino che divideva con Vittorio Mezzogiorno, a salutarlo. In pizzeria mi raccontavano dei loro progetti, Cieslak sarebbe andato in Danimarca, Vittorio tornava al cinema con un Pirandello… Dopo pochi anni ho saputo che Ryszard, in America, era malato…, poi anche Vittorio. Del Teatr Laboratorium oggi sono belle e vive le due donne, Elizabeth e Rena Mirecka. Zygmunt Molik credo abbia più di ottantanni.
HY – Delle immagini scattate ad Apocalypsis cosa ne ha fatto?
M.B. – Praticamente nulla. Delle stampe date alla compagnia credo non ci sia più traccia. Quei negativi non li ho più usati, se non per due tre immagini nei miei libri, o su qualche rivista: quella iniziale di Cieslak, il “santo” accucciato contro la colonna e quella finale, quando è a terra e gli altri gli incombono sopra con le candele. Un paio d’anni fa, poi, ho iniziato a lavorare con gli scanner per digitalizzare qualche capitolo del mio archivio e un giorno sono arrivato su Apocalypsis. Dai negativi, molto critici, ho ottenuto un risultato, oggi praticamente inedito, che sarebbe stato difficile conseguire in camera oscura. Poi con il Centro Grotowski in Polonia abbiamo pensato di realizzare una mostra nella sala storica del Teatr Laboratorium, per il decennale della morte del regista: ho lavorato complessivamente a circa 150 immagini, delle quali 80 si riferiscono a Apocalypsis, mentre le altre agli anni seguenti e ai tentativi di alcuni dei componenti del Gruppo di sopravvivere teatralmente allo scioglimento. Ora queste fotografie, come un piccolo Fondo che comprende anche alcuni ritratti di Grotowski, fanno parte dell’archivio storico di Wroclaw.
HY – In seguito deve aver incontrato Grotowski più da vicino, se gli ha fatto alcuni ritratti…
M.B. – Sì, era tornato dagli Stati Uniti: si era rifugiato a Pontedera, viveva e lavorava al Workcenter con Thomas Richards e Mario Biagini. Mi ha chiamato Mario per chiedermi se ero disposto a realizzare dei ritratti. Scherzando mi diceva che Grotowski pensava a un ritratto «da lasciare per il futuro, per la sua scomparsa». Mi si chiedeva di mantenere la cosa riservata. Arrivo al Centro di Pontedera e lo trovo deserto perché erano partiti tutti per una tournée in Sud America. Erano rimasti solo loro tre. In una delle sale del Centro ho preparato un piccolo set con un fondale nero e un paio di luci e ho atteso che Grotowski arrivasse. Non stava bene, si doveva risparmiare molto e forse, pensavo, si continuava un po’ a giocare con la faccenda dell’aura. Insomma, l’incontro veniva rimandato di ora in ora, e sono passati così un paio di giorni. Mi annunciavano che si sarebbe potuto fermare solo mezz’ora e perciò dovevo essere pronto e veloce. Furono due giorni di attesa, di piccoli preparativi e anche di un po’di ansia da parte mia. Mi faceva chiedere come, secondo me, doveva vestirsi. Suggerivo di portarsi un paio di abiti, ma che l’abito migliore sarebbe stato quello che lui preferiva. È arrivato di notte, con la valigia degli abiti. E abbiamo iniziato a chiacchierare. Di Kantor.
HY – Lei Kantor lo ha seguito a lungo. Aveva mai discusso di Grotowski, con lui?
M.B. – No. Però Kantor, con me presente e in un paio di occasioni – mi pare durante il tè coi biscotti – ne ha parlato malissimo. Lo accusava di essere stato uno di quei “funzionari” del potere che gli avevano impedito di uscire dalla Polonia. Credo si riferisse soprattutto a chi si occupava della “comunicazione” nell’entourage a Wroclaw. Chiamava Grotowski «gigolò della cultura». Sapeva che avevo fotografato Apocalypsis perché ne aveva parlato con alcuni suoi attori, ma con me direttamente non ha mai toccato l’argomento. Credo per evitare occasioni di scontro. Ma questo è un altro racconto.
HY – E Grotowski, cosa disse di Kantor quel giorno a Pontedera?
M.B. – Iniziò ricordando, in maniera per me gratificante, le fotografie di Apocalypsis. Poi mi sorprese, ma forse un po’ me l’aspettavo, parlando delle mie immagini degli spettacoli di Kantor, dicendo che conosceva le opere di Kantor attraverso le mie fotografie. Le definì un lavoro «tres remarquable», che permetteva anche a chi non aveva avuto esperienza diretta di Kantor di apprezzarne il valore. Mi dava la misura della sua intelligenza anche nel chiedermi cosa avevo tratto dalla frequentazione così intensa di un artista così grande… Mi sarebbe piaciuto parlarne con calma, magari a lungo, ma io ero anche sulle spine, sapendo che lui poteva posare solo per mezz’ora…
HY – E i ritratti?
M.B. – Abbiamo aperto la valigia degli abiti e me li ha mostrati. La prima era una giacca nera, l’altra anche, l’altra ancora pure. E poi c’erano camicie, tutte bianche, e cravattini verdi o rossi, che in bianco e nero avrebbero avuto la stessa tonalità… Era sottilmente e piacevolmente ironico, siamo andati avanti nel gioco delle prove e gli ho fatto vari scatti, anche con un banco ottico. Era diligentissimo, fermo fermo e fisso “in macchina” come gli chiedevo. Mi sembrò fisicamente provato, ma bello. La seduta durò davvero poco più di mezz’ora, poi lo portarono via. Ora ho scelto quello che considero il ritratto definitivo di Grotowski, un’immagine in cui ha un’aria importante, una grande barba e i capelli bianchi. È diretto verso chi guarda, solenne. Insieme a lui ho fotografato anche Thomas Richards: l’immagine dei due volti era per la copertina del libro in cui Thomas diventa suo erede.
HY – Che immagine dell’artista Grotowski, dell’uomo Grotowski, riemerge da questo suo archivio?
M.B. – Ho intitolato la mostra Polvere. Ho pensato a ciò che lui sapeva di essere e a ciò che è divenuto. È un album di esperienze e persone lontane, di esistenze scomparse, di esseri umani che hanno vissuto, che ho veduto vivere, che ho cercato, anche se labilmente, di trattenere. Nel mio archivio forse conservo l’immagine di un uomo che si è fatto povero, fino a rinunciare al suo nutrimento essenziale. Il suo genio è progressivamente coinciso con la storia della sua anoressia teatrale.
Tag: FlaszenLudwik (2), fotografiaeteatro (5), Jerzy Grotowski (29), Tadeusz Kantor (7)
1 Commentoa“Grotowski in bianco e nero”
Scrivi un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.


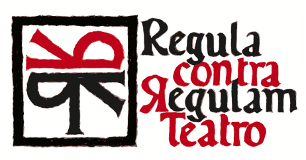




Zygmunt Molik ci ha lasciato, purtroppo, nel 2010, Mario Barzaghi.