|
Descrizioni d'interni
Una nota sul teatro di Giorgio Barberio Corsetti
di Chiara Ferrari
C’è sempre un nuovo spettacolo da fare fortunatamente. Finire uno spettacolo, porre un termine è una contraddizione assoluta, come voler significare un movimento stando assolutamente fermi, o uno sognando con le palpebre chiuse. Eppure dolorosamente si taglia il flusso, si pone un blocco e si ammassa, si ordina e si sviluppa, si costruisce e si lavora, insomma. Si lavora attorno a qualcosa che è la negazione del lavoro, che è sofferenza o rapimento, mai fatica, eppure diventa fatica. E man mano che si stringe ci si sente dei ciarlatani, perché sembra che tutto sia perduto. Fortunatamente qualcosa resta.
Giorgio Barberio Corsetti
Il teatro di Giorgio Barberio Corsetti è un flusso di materia che, alternando lo stato liquido a quello gassoso, si modifica e dà luogo ad uno scorrere vitale ed inarrestabile e, con esso, al trapassare dei significati e delle forme, in nuovi significati ed altre forme. Ogni singolo aspetto ne è la conferma: l’elaborazione di uno spazio scenico sempre mutevole, per esempio, risultato di una profonda riflessione intellettuale, che tiene conto della scenografia, (casa o tana che sia) come dimensione da abitare, da indossare sul corpo e da vivere, rivelando, in questo, una forte carica metateatrale, perché il teatro è il luogo dell’esistere: è protezione, rifugio, schermo illusorio; e del luogo, come porzione di spazio, da adibire simbolicamente ad altro, ad una parte di mondo o di corpo attorno a cui costruire percorsi.
Al periodo della Post-Avanguardia (metà anni ’70) appartiene l’idea dello spazio come concezione esistenziale (“spazio utopico”, “spazio illusorio”), luogo privilegiato in cui inscenare lo scontro diretto con la realtà; la sua definizione diventa precisa scelta politica che sottintende la messa in discussione delle regole, implicita, per esempio, nello sconfinamento dal luogo scenico deputato e nell’utilizzo di prospettive sghembe, alteranti la visione dello spettatore e la tradizionale demarcazione tra scena e platea (Cronache marziane,1977).
Gli spettacoli realizzati in collaborazione con Studio Azzurro (Prologo, 1985, Correva come un lungo segno bianco, 1986, La camera astratta, 1987), nati sulla scia delle prime sperimentazioni video, prodotto della logica post-moderna, e risultato della profusione dei codici sottoposti all’estetica della ripetizione, sono giocati sul rapporto tra spazio reale e spazio illusorio creato dai monitor. Essi danno corpo ad uno “spazio organico” (Valentina Valentini), organismo pulsante all’interno del quale si ricompone l’unità di psichico (il pensiero) e fisico (il corpo, la materia), compressi all’interno di una stessa dimensione: sostanza viva (corpi-voci-suoni) e forma inerte (simulacri-oggetti-immagini tecnologiche). In queste sperimentazioni il monitor è il generatore di uno spazio illimitato, capace di alterare la normale percezione delle profondità e della prospettiva al punto da dare consistenza ad una realtà astratta (La camera astratta) come lo spazio mentale, lo spazio del pensiero, o come la dimensione interiore. L’opera-video è, infatti, la rappresentazione in termini concreti di uno spazio totalmente indefinito: quello del pensiero di un soggetto, che agisce in uno stato di sospensione temporale. E la scelta dell’inquadratura costituisce ancora una scelta politica, poiché mostra una porzione di mondo piuttosto che la sua totalità.
Con Descrizione di una battaglia (dai Racconti di Franz Kafka, 1988) un muro bianco viene a rappresentare la tana all’interno della quale ci si rifugia: è lo spazio dei conflitti, delle angosce e delle paure; apparentemente solido, si dimostra presto tarlato e pieno di cunicoli: i percorsi sotterranei di quella dimensione interiore in cui ci si addentra per nascondersi, ma dove alla fine “tutto invece rimane immutato”.
America (da Franza Kafka, 1992) circoscrive le tappe di un viaggio iniziatico che si realizza nelle forme di uno spettacolo itinerante, all’interno del quale viene attivata una dinamica comunicativa che, ancora una volta altera il normale rapporto dello spettatore con la scena, secondo percorsi non inediti al regista romano, ma ora arricchiti di un senso forte che tiene conto dei significati, e che immerge lo spettatore nel preciso gioco identificatorio di una laica via crucis.
Con Il processo (da Franz Kafka, 1998), gli spettatori sono di nuovo invitati a seguire le spire di un procedimento, che è un procedere per scene, tappe, luoghi e momenti dell’esistenza di un protagonista, collocato all’interno di un universo ricostruito secondo coordinate puramente mentali, in cui l’esterno è la proiezione di un mondo interiore, popolato di fantasmi e figure distorte, ed in cui lo spettatore ha facoltà di insinuarsi per sbirciare tra gli angoli di una città della mente, trasportato da gradinate mobili.
Come lo spazio, anche il corpo è sottoposto ad alterazioni che investono la dimensione fisica e mentale dell’attore; in accordo ai principi della danza, e soprattutto alla considerazione di esso come il più eloquente strumento di comunicazione, il corpo è vessato, spezzato, scomposto, gettato a sfidare le leggi di gravità. E’ un corpo fatto di carne e che parla un linguaggio denso, di una carica selvaggia e sensuale, quasi animalesca, un corpo che si trasforma, presente anche in veste di ombra asettica e di simulacro silenzioso (nelle proiezioni o all’interno dei monitor); un corpo che si esprime attraverso un codice di gesti, rivestito di un tessuto analogico e poetico (Il legno dei violini, 1990 è un saggio di teatro-danza); un corpo che dà consistenza a personaggi, figure-funzioni-metafore dal carattere sfaccettato e poliprospettico, forme fluttuanti che giocano a confondersi nell’ambiguità di un’identità variabile e multipla, perennemente in bilico tra la perdita di sé e la perdita di gravità (la Signorina, il Vicino de Il legno dei violini, le figure femminili de Il processo, il Karl di America, il doppio de Il corpo è una folla spaventata, 1996...). Ma, soprattutto, ci sono l’ironia e il disincanto, (proprie soprattutto degli anni de La Gaia Scienza), che altro non sono che le prospettive distorte e alterate della realtà, giocose e divertite, ma spesso celanti una dimensione più angosciante e claustrofobica (il senso di smarrimento e la perdita di equilibrio dei corpi a testa in giù, la claustrofobia prodotta dallo sforzo degli stessi corpi incastrati nelle scatole dei monitor, da cui cercano di evadere in La camera astratta, il senso di soffocamento espresso dai corpi che strisciano lungo i cunicoli interni di una tana di gesso in Descrizione di una battaglia, l’oppressione e la costrizione fisica e psicologica che si percepisce all’interno della casa-armadio de Il legno dei violini...). E poi: l’uso degli oggetti come metafore essenziali su cui scorrono significati mutevoli e incostanti; le macchine sceniche, giostre che spesso ingabbiano il corpo divenendone una tragica estensione; il canto e la musica come testi primari; il video come sconfinamento e contaminazione; il senso e il non-senso; la dimensione interiore, della mente o dell’anima; la leggerezza impalpabile della poesia e la solida concretezza degli elementi primari: la terra, il fuoco, l’acqua, l’aria, il maschile e il femminile.
Sono gli assi portanti di un universo poetico che, nel tempo, si è sviluppato nella direzione di una ricostruzione del senso, dopo la fase dell’azzeramento, e che ha portato il regista-attore-autore romano, ad abbandonare le riflessioni più analitiche sul linguaggio e sui mezzi teatrali (in poche parole sui significanti), per aprirsi a considerazioni più ampie sui significati, sul valore e sulla funzione del teatro, sulla ricerca dell’identità (America), sulla profondità della dimensione interiore e dell’anima, o sul sacro (Graal). Questo è avvenuto anche grazie ad un particolare rapporto con la letteratura, segnato soprattutto dall’incontro-immedesimezione con Kafka, una delle “porte regali” attraverso cui entrare (o uscire) per accedere alla dimensione del “fuori del teatro”, ed utilizzare il linguaggio come veicolo di un messaggio o di un contenuto extralinguistico e, quindi, come strumento di riflessione sul mondo, o sull’individuo, di cui mettere a fuoco, ferocemente, le angosce e le paure.
Brevi cenni storici inquadrano l’itinerario artistico del regista romano attorno alle esperienze maturate nel contesto del fenomeno della Post-Avanguardia (nata intorno alla metà degli anni ’70 sulle ceneri dell’ormai istituzionalizzato Teatro-Immagine, si prolunga fino alle soglie degli anni ’80, quando essa diviene il prodotto del post-moderno, l’espressione polimorfa di quella che Maurizio Grande definisce “Nuova Babele”), insieme al gruppo storico La Gaia Scienza da esso fondato nel 1975 e successivamente sciolto nel 1984; un percorso che ha come punto di partenza il rigetto delle forme del teatro tradizionale, in accordo ad un’ipotesi di rifondazione totale dei codici, sulla base degli elementi primari, il corpo e lo spazio, elevati a medium di un discorso non-rappresentativo. Il percorso del regista si snoda lungo un processo di crescita compositiva segnata, dopo la lunga fase di afasia, dall’acquisizione della parola che, inizialmente si pone come voce narrante di un universo interiore, poi, sempre più, si rivela come veicolo e oggetto di scambio primario attraverso cui costruire un racconto, all’interno del quale viene messo in scena lo scontro con il reale, dando così, forma alla ridefinizione di un senso (America rappresenta il momento del passaggio, il confronto con una drammaturgia complessa come un romanzo di formazione, il desiderio di affrontare tematiche impegnative: l’ingresso nel mondo del lavoro, le responsabilità, l’età adulta, la ricerca di un posto in cui stare, e, con esse, l’adozione consapevole del racconto e della parola). Già con Prologo si esplorava il mondo della soggettività e del pensiero, attraverso la scrittura, luogo di contemplazione e finestra privilegiata attraverso cui guardare l’esterno, e per mezzo della voce del narratore che scopriva il paesaggio evocandolo con le parole di un viaggio interiore, quasi come se esso potesse esistere solo se nominato. Ma è solo con la scoperta dell’universo letterario che Barberio Corsetti dà voce e forma concreta ad un ‘Teatro totale’, un organismo strutturato e costruito attorno alla trascrizione scenica di una scrittura letteraria, contenente tutti gli elementi di un gioco complesso, stretti in una ideale fusione: il corpo, il personaggio, la scenografia, lo spazio, la letteratura, la parola che racconta, il video, i significati. E Kafka diventa il luogo perfetto di un incontro che scatena l’inevitabile immersione nelle profondità delle grandi angosce dell’io, per la fisicità di una scrittura che riesce a svelare quell’oltre celato e non immediatamente evidente; come un “codice di gesti” (W. Benjamin, Angelus Novus), un linguaggio geroglifico tracciato sul corpo o con il corpo, essa è perfettamente compatibile con il teatro di Barberio Corsetti, in cui il gesto agisce nella direzione di uno sfasamento rispetto al linguaggio, creando un’apertura, una piega, uno scarto, all’interno del quale si inserisce la possibilità poetica, quella che sa svelare significati sotterranei resi straordinariamente visibili spesso dall’ingrandimento di dettagli insignificanti, dalla serialità, dalle immagini distorte o spezzate riprodotte dalle video-installazioni.
Lo spettacolo Graal (adattamento da Chrétien de Troyes e Wolfram von Eschenbach, 2000), realizzato in occasione dell’anno giubilare, si pone come nuova tappa di un percorso di ricerca, che affonda le sue radici nella materia densa e perturbante del mito; pur con il consueto distacco ironico, da essa viene carpito il più profondo significato simbolico, secondo una personale visione del regista, che affronta la vicenda del Graal, delineando una prospettiva che mette in gioco la dimensione molto intima e personale della ricerca del sacro, inteso come contatto, profondo e silenzioso, con l’anima. “Il Graal è il cuore verso cui si viaggia per trovare il centro di sé stessi. Vorrei che attraverso l’emozione si cogliesse la tragedia del non essere in contatto profondo con il proprio spirito, della perdita del sacro che è in ognuno di noi”. (Giorgio Barberio Corsetti)
Il significato che lo spazio scenico assume nelle intenzioni di Barberio Corsetti, e cioè di luogo attraverso cui riflettere sul mondo, attraverso gli elementi costitutivi del Teatro, ha inserito lo spettatore nella condizione di affrontare un percorso a stazioni, attraverso cui ricostruire l’itinerario fisico e mentale che, sulla scia delle peripezie che capitano ai personaggi, lo invita ad interrogarsi sulle reali questioni poste in gioco: che cos’è il Graal, se non ciò che sfugge, ciò che non si può raggiungere perché non si è in grado di ascoltare la voce dell’anima? E che cos’è l’amore: un vincolo? Una schiavitù? Una prigione? Un’ossessione? Una forza annientatrice?
Con Woyzeck (di Georg Büchner, 2001) Barberio Corsetti si interroga sul rapporto tra l’umano e il bestiale, mettendo in discussione il concetto stesso di umano: il Woyzeck soldato-bestia, cavallo-asino e Maria-donna-lupa inscenano uno scontro di elementi primari giocato sullo sfondo di un teatrino da alchimista fatto di personaggi-metafora, a volte entità metafisiche, di scambi rapidi, di ossessioni: i frammenti ideali di una tragedia, contaminata dei segni di un disastro inevitabile. Uno spettacolo che parla del “dualismo tra natura ordinaria e altra natura, quella che si anima, che esprime i propri segni, decifrabili come una lingua nascosta, una natura in rapida degenerazione, una natura che diventa vuoto, silenzio e morte”. (Giorgio Barberio Corsetti).
Dopo l’esperienza francese de Le Festin de Pierre (da Don Giovanni di Moliere), in scena al Théâtre National de Strasbourg, e realizzato con gli attori del TNS, con il prossimo spettacolo atteso alla Biennale di Venezia (Metamorfosi di Ovidio, 12>14 settembre), Barberio Corsetti intende appropriarsi del linguaggio del circo, utilizzando corpi di attori-acrobati, per tornare a parlare di mito, inteso come momento di trasformazione, di passaggio tra mondi diversi, quello vegetale, animale, umano e divino, ed in cui il sacro rappresenta il segno tangibile di una inevitabile metamorfosi: “si raccontano metamorfosi, costellazioni splendenti che rimangono per sempre piantate nel cielo, salti, balzi animaleschi, inseguimenti acrobatici, uomini e donne trasformati in lupi, cervi, orsi, alberi. Un mondo fluttuante non ancora definito che si lascia pervadere da un sacro oscuro, lancinante, violento.” (Giorgio Barberio Corsetti).
Dagli archivi di olivieropdp,
# un'intervista a Giorgio Barberio Corsetti;
# La recensione di Oliviero Ponte di Pino a America, pubblicata sul "manifesto nel 1992:
Nel riallestire America a Milano (qualche mese dopo il debutto di Cividale e una edizione "indoor"), Giorgio Barberio Corsetti ha invaso il tessuto della metropoli. Zone di transito e passaggio (treni, stazioni) e zone in trasformazione (periferie degradate, capannoni in disuso, terrains vagues) fanno da sfondo all'odissea di Karl Rossmann in un'America immaginaria e profetica, e circoscrivono il flusso dei suoi vagabondaggi. Le avventure del giovane praghese, scacciato dalla natia Praga per aver sedotto una domestica, seguono tutte il medesimo schema: dapprima l'illusione (l'amicizia, la ricchezza, l'amore, il lavoro...), poi - come se riemergesse puntigliosamente l'antica colpa - la caduta. America è dunque il rovescio di un romanzo di formazione, una serie di variazioni sul mito del fallimento: non appena l'eroe sta per raggiungere un faticoso equilibrio, un embrione di identità, si ritrova nella trappola di doppi legami che rendono ogni sistemazione instabile e riaprono dolorosamente la ferita dell'abbandono. Dunque eccolo scivolare di nuovo, cacciato e sospinto verso un altro incontro, un'altra avventura.
Lo spettacolo segue questo beffardo e tragico percorso di iniziazione intessendo nel tessuto urbano parole, corpi e gesti che lo trasfigurano. Il porto di New York (dove Karl prende le difese del "fuochista", che verrà ugualmente punito) è il binario 1 della Stazione Nord, e il transatlantico è un treno. Lo stesso treno (con il suo carico di "normali" viaggiatori) porterà personaggi e spettatori verso i graniti e le porte automatiche della modernistica stazione della Bovisa, dove abitano lo zio d'America Jakob e la giovane e isterica Clara. Poi, visto che né i miliardi né l'aggressiva sensualità della ragazza fanno per lui, l'angosciato Karl si incammina verso un padiglione industriale di sorprendente verticalità: è l'Albergo Occidentale, dove troverà qualche invadente amicizia (materna e sororale) e un impiego come "ragazzo degli ascensori". Ma neppure il lavoro è il suo destino: Karl ricade nelle grinfie di due vagabondi, piccoli criminali, e della cantante Brunelda, con la sua travolgente follia. E quando anche questa soluzione si rivelerà precaria e umiliante, Karl si unisce al Teatro Naturale di Oklahoma, grottesco Aldilà ambientato tra il fango e le pozzanghere, dimenticati tra la nuova faraonica stazione, e la modesta e fatiscente banchina di quella vecchia. Alla fine, il cerchio dello spettacolo si chiude sull'immagine iniziale: una Statua della Libertà che, al posto della torcia, impugna una spada. Karl Rossmann, come all'inizio, è insieme colpevole e innocente, ingenuo e perdente: nella lotta tra se stesso e il mondo ha continuato infallibilmente, pur senza avere alcuna identità, a scegliere se stesso.
All'inizio la Milano di America profuma malinconicamente di nostalgia: tra quei binari riecheggiano infinite esistenze tutte uguali, gli eterni ritorni dei pendolari. Se poi la città mette in mostra il suo forzato e trionfalistico amore per il futuro, lo rovescia immediatamente in un rugginoso passato paleoindustriale, nel deserto di una fabbrica in disuso. Finché, nell'ultima scena, questo corpo metropolitano non rivelerà il suo squallore, le sue ferite.
Questi diversi luoghi vengono contaminati e straniati dall'azione scenica, distorti dall'irruzione di una diversa forma di realtà. Le esperienze e le memorie di chi li vive e li attraversa quotidianamente collidono con l'immaginario che vi viene proiettato - mentre la regia fa riemergere gli elementi costitutivi (aria, fuoco, lastre d'acciaio) di un mondo primordiale. E il meccanismo dialettico e ironico, minimale e visionario, di teatralizzazione e demistificazione di uno spazio finisce per sovrapporsi alle illusioni e disillusioni del protagonista.
Da Kafka, oltre al plot, Barberio Corsetti ha ricavato anche i "geroglifici gestuali" (un alfabeto di tic, atteggiamenti, camminate, posture), che caratterizzano i diversi personaggi, fino a costituire l'ossatura di una coreografia. Ma c'è in America anche un embrionale aspetto circense: a volte clownesco, soprattutto nel caso di Gabriele Benedetti, che disegna un Karl Rossmann in perenne movimento, fragile e vulnerabile, che trasforma la sua inquietudine in una continua vibrazione, il suo precario equilibrio in una continua spinta propulsiva, come un Charlot intrappolato dagli ingranaggi del mondo; a volte acrobatico, come accade con i due vagabondi Delamarche e Robinson, che finiscono quasi per assumere le sembianze di uccelli, appollaiati su fili sospesi a mezz'aria.
Da un lato, in America, vengono utilizzate le tecniche "povere", insieme concrete e allusive, della performance (quelle messe a punto negli anni della Gaia Scienza), a partire dalla convinzione che la conflagrazione estetica possa essere determinata dalla compresenza di realtà di ordine diverso: sei attori (oltre a Benedetti e Barberio Corsetti, Milena Costanzo, Alessandro Lanza, Roberto Rustioni e Federica Santoro) per dare vita a decine di personaggi e situazioni, l'evento viene costruito come esplosione di energia fisica e pulsioni elementari, l'evento artistico si sovrappone alla realtà, viene prestata l'attenzione ai materiali primari e alla struttura dello spazio, il pubblico viene chiamato a spostarsi e a interagire con l'evento. Ma nel contempo la trama romanzesca viene sostenuta dall'immissione di elementi letterari, musicali (Daniel Bacalov, Harry De Witt, Carlos Zingaro e, dal vivo, Massimo Munaro) e coreografici, e dall'allusione alla coincidenza tra corpo e scrittura, tra interiorità e mondo, tra romanzo e continente. Lo spettacolo di Giorgio Barberio Corsetti sembra così aspirare all'Opera d'Arte Totale: che non è più concepibile nell'isolamento di uno spazio teatrale, ma deve necessariamente contaminare anche la realtà. E, al termine del percorso, America, assume il valore di una scrittura che s'inscrive in bassorilievo sul corpo dellla città, una spettacolarizzazione precaria e volatile, un graffito della memoria che gioca (forse illudendosi) a modificare la percezione del mondo.
|
|
Riciclare l'ordine
Expo.02
Regione dei Tre Laghi - Neuchâtel-Morat-Bienne
Fino a 20 ottobre 2002
di Francesco Niccolini
Svizzera, territorio miracoloso e miracolato in fragile equilibrio fra natura e tecnologia. Dove tutto è in ordine ed ogni indigeno sa dove parcheggiare la propria auto, gettare la bottiglia verde e quella trasparente: storica incarnazione della neutralità assoluta (solo quest’anno la maggioranza dei suoi abitanti ha deciso di aderire all’ONU), potrebbe essere il terreno ideale per un’ampia riflessione sullo sviluppo sostenibile e su tutto quello che in qualche modo riguarda il destino dell’umanità e del pianeta. E’ proprio questo l’ambizioso tema scelto per l’
Expo 2002, visitabile fino al 20 ottobre prossimo nella zona dei tre laghi: Neuchâtel, Bienne (Biel, per gli svizzero-tedeschi), Morat (Murten) ed Yverdon-les-Bains. Considerando la concomitanza con il summit di Johannesburg, questo contraltare neutrale e popolare, adatto ad accogliere centinaia di migliaia di visitatori (3 milioni fino ad ora, di cui 400.000 stranieri) è indubbiamente una scelta condivisibile.
Splendida la cornice (vivamente consigliato il battello per spostarsi da un sede all’altra), splendidi i paesi, a partire da quella piccola Praga svizzera che è Neuchâtel, forse non a caso scelta per il suo ‘esilio’ da una scrittrice straordinariamente kafkiana come l’ungherese Agotha Kristof. Per tre giorni provo a muovermi tra le quarto Arteplage predisposte: Arteplage, arte e spiaggia, spiagge dedicate all’arte. Le quattro città, amabilmente appoggiate al lungo lago, uniformano esteticamente gli spazi espositivi offrendo le proprie incantevoli ‘discese a mare’ alle installazioni. L’impatto è sorprendente quanto suggestivo: acqua e terra, palafitte tecnologiche, torri, ponti, passerelle, addirittura una gigantesca nuvola artificiale (ad Yverdon, vento permettendo) ed un monolito gigantesco (Morat). Tutto sull’acqua, tutto estremamente moderno e contemporaneo, eppure con una strana sensazione di preesistenza e di antico. Ferro, legno e materiali sintetici si mescolano di continuo, secondo l’assioma di un recupero della materia naturale, ecologica e riciclabile che però non vuole sbattere la porta in faccia alla materia artificiale cui non si può più rinunciare. Con consapevolezza e misura, però. E se un limite si può riscontrare in tutto questo approccio è proprio nello straordinario buon senso che si respira in tutti questi spazi e nel cortese comportamento di tutti, dal sorridente personale di ogni singolo spazio all’ordinatissimo pubblico che fa code orarie per entrare dappertutto, allietato dagli artisti di strada e dai piccoli doni dell’Expo (verdissime mele biologiche imperversano per tutta Neuchâtel).
A Morat il tema portante è il Tempo, a Neuchâtel l’Artificio, Yverdon riflette sull’Universo, mentre Bienne è il luogo del Potere e della Libertà. Fatalmente il simbolo di quest’ultima sono tre torri che fra i tanti significati proposti dall’Expo, ad un anno esatto dall’11 settembre 2001 forse ne assume uno più inquietante: diventano infatti una gigantesca torre di Babele intorno alla quale è difficile capirsi e distinguere concetti fondamentali: prezzo, valore, immagine reale e pubblicitaria.
All’ingresso dell’Arteplage di Neuchâtel un gigantesco geode in legno (rigorosamente riciclato dall’Expo di Hannover di due anni fa e già pronto per un nuovo uso...) sintetizza disgrazie e contraddizioni del pianeta, per poi proporre gli estratti della dichiarazione dei diritti dell’uomo. L’accostamento risulta una delle più perverse e feroci forme di ironia (volontaria?) che il cronista cisaplino possa immaginare, a conferma delle contraddizioni di un pianeta dove predicare bene e razzolare sporco è regola applicata ben oltre il buon senso dei ricchi e dei potenti.
Impossibile restituire l’innumerevole vastità e varietà delle installazioni e delle tematiche: tutto è sensuale e sensoriale, la scelta (eccezion fatta per parte delle installazioni di Morat) è antimetafisica. D’altra parte, nell’immenso spazio di tutto ciò che è universo sensibile, la proposta è praticamente infinita: a Yverdon prevalgono amore, dolori, sogni (migliaia quelli raccolti in tutta Europa da bambini tra i 5 ed i 13 anni), salute, sport. Neuchâtel è il regno dell’Intelligenza Artificiale, dunque di Pinocchio, dell’acqua e dell’energia elettrica, della robotica e dei cataclismi naturali. A Bienne si guarda e si discute di frontiere, di lingue, di industrie, soldi e valore, di felicità e territori immaginari, tutti temi particolarmente cari alla Svizzera (in questo, Bienne è sicuramente la sezione più folkoloristica dell’Expo: assolutamente imperdibile la visita, dentro un carrello della spesa, di tutte le bellezze ed i valori d’Oltralpe, Heidi, esercito e lingotti d’oro compresi, all’interno di un padiglione-luna park-museo delle cere e degli orrori insieme sponsorizzato da una grande catena di supermercati svizzeri...).
Infine, nella bella Morat si inseguono i segni del tempo, dell’istante e dell’eternità, tra la nostalgia di mondi perduti per sempre ed i rischi della guerra e della violenza (assolutamente da non perdere è la visita in battello verso il Monolito, all’interno del quale ammirare il restaurato Panorama della Battaglia di Morat, dipinto circolare di fine Ottocento di centoundici metri di circonferenza), la cecità (altra esperienza eccezionale e realmente dolorosa la visita al Blindekuh, dove si entra solo su appuntamento e dove, nel buio più assoluto, si viene accompagnati da personale cieco a fare esperienza quotidiana della vita senza vista, in un incubo alla Saramago), e la fantasia inarrivabile e sfolgorante del nostro amico e maestro, Antonio Catalano da Asti, che ha potuto esporre quadri, pietre, piume ed armadi (‘sensibili’, giustappunto) in un teatro costruito appositamente per l’Expo sotto una pietraia.
E sicuramente la visita di Morat è quella poeticamente più affascinante agli occhi del visitatore in cerca di arte: messe da parte le grandi strutture tecnologiche e ipermoderne, qui domina la ruggine. Città ed Expo non sono separate da cancelli di ingresso, ma una vive dentro l’altra con segnaletiche uniformate che rendono davvero indistinguibili le installazione fatte ad hoc dalle strutture preesistenti. Una lunga via crucis di edicole rugginose (come in una sacra rappresentazione cinquecentesca) ai bordi del lago aggiunge una inquietudine metafisica che le certezze della tecnologia avevano fatto rimpiangere al più incallito dei cronisti atei. Negli spazi antichi, teatrali e bui di Morat, finalmente troviamo anche noi un prato dove addormentarci e sognare mondi migliori.
|
|
Metamorfosi elettroniche
oVMMO : : ovidiometamorphoseon
di Alessandra Giuntoni
Prima del mare e della terra e del cielo che tutto ricopre, unico e indistinto era l’aspetto della natura in tutto l’universo, e lo dissero Caos, mole informa e confusa, nient’altro che peso inerte, ammasso di germi di cose mal combinate. Nessun Titano ancora donava al mondo la luce, né Febe ricolmava crescendo la sua falce, né la terra, trovato il proprio equilibrio, stava immersa e sospesa nell’aria, né Anfitrite aveva proteso le braccia a recingere i lunghi orli della terraferma. E per quanto lì ci fosse la terra, e il mare, e l’aria, instabile era la terra, non navigabile l’onda, l’aria priva di luce: nulla riusciva a mantenere una sua forma, ogni cosa contrastava le altre, poiché nello stesso corpo il freddo lottava col caldo, l’umido con l’asciutto, il molle col duro, il peso con l’assenza di peso.
Così Ovidio, in apertura delle Metamorfosi, per introdurci nel colossale poema cinematografico in cui ogni verso, come un fotogramma, è ricco di stimoli visuali in movimento, in cui il tempo che domina è l’assoluto presente, dove tutto avviene sotto i nostri occhi e i fatti incalzano frenetici a ribadire che ogni distanza tra noi e la narrazione ci è per sempre negata. La stessa materia magmatica, lo stesso horror vacui che domina lo spazio del poema, attraversa oVMMO a firma XEAR.org, lo spettacolo andato in scena al Festival AVIGLIANA SOGNA 2002 nella sezione “Visioni Sonore, sincronismi… live theatre/live sound”, tenutosi ad Avigliana (TO) dal 13 al 27 luglio; organizzazione e scelte artistiche a cura di Opus rt Servi di Scena.
La session per tecnologie audio e video di e con Mauro Lupone, Massimo Magrini, Marco Sodini e Giacomo Verde sviluppa partiture visive e sonore elettroniche sospese su percorsi di creatività digitale a veicolare derive acustiche di inesplosa sonìa, spettri di frequenze microtoniche ed incerte sedimentazioni segniche. Le misteriose e tecnologiche macchine sonanti, composte da sintetizzatori e da software per l’elaborazione informatica del suono (l’interfaccia ad infrarossi, azionata dal programmatore e musicista noise Massimo Magrini/Bad Sector, è qualcosa di così sorprendente che il pubblico stenta a capire che di musica live si tratta), interagiscono con una complessa videomacchina scenica operante sul principio del loop. Una telecameracamera digitale inquadra un computer portatile sul cui schermo trans-corrono sequenze catturate in diretta dalla webcam rivolta allo spazio scenico. Su questo flusso ininterrotto di ripresa, il tecno-artista Giacomo Verde interviene per tutta la durata della performance sovrapponendo oggetti e riflessi ottenuti da un lucido trasparente appoggiato sullo schermo, generando immagini trasmesse in videoproiezione sul fondale fluorescente. Il tutto rigorosamente live, a riconferma che le nuove tecnologie dell’interattività e della multimedialità, quando sono in grado di modificare la modalità di azione del performer e la fruizione dello spettatore, producono un cortocircuito sinestetico davvero avvolgente, un ambiente sensoriale di ricezione modificato e continuamente automodificantesi capace di recuperare tutta l’aura e la magia di una moderna e ipertecnologica opera d’arte totale.

Al centro di questa entità spettacolare densa, ibrida ed immersiva (sicuramente unica nel panorama italiano della scena multimedia) sta un corpo/voce d’attore (un convincente Marco Sodini) a sua volta presenza metamorfica in bilico tra lontananza e inneità, biomacchina impegnata in un raffinato studio sulla gestualità - il corpo come iperstrumento su cui intervenire e sperimentare - e con la dizione del testo di Ovidio, quest’ultima molto classica e curata. L’elaborazione drammaturgica, dello stesso Sodini, procede secondo un metodo analogico e visuale, dando vita ad una puntuale ritmica scenica in cui la partitura gestuale è saldamente legata al montaggio delle sequenze narrative. Ciò assicura quell’effetto di continuità e mobilità del tutto, quel senso di trapasso universale della materia, che da sempre costituiscono lo stigma del barocchismo di Ovidio, la nota distintiva della sua visionarietà postmoderna. Ma la varietà tumultuosa dei mitologemi ovidiani è resa, in oVMMO, da una pluralità di proposizioni polisensoriali, da un florilegio di sollecitazioni ibride che restituiscono il senso di permeabilità dei media, della loro instabilità, della loro reversibilità. La spazializzazione del suono, ora bianco rumore elettronico e informativo, ora nero rumore di fondo, torbido come la pece a scandire un tempo assoluto e metropolitano, è resa nelle immagini del videofondale da un fluire montante di giochi cromatici in cui si delinea sempre più la ricerca di una simultaneità plastica e sensitiva che, attraverso la poetica del frammento, evolve verso ritmi astratti e bidimensionali.
Giacomo Verde è tra i primi videoartisti italiani a realizzare opere di arte interattiva e net-art; il suo lavoro si caratterizza per “riflettere, sperimentando ludicamente, sulle mutazioni tecno-antropo-logiche in atto” ed ha come costante la creazione di connessioni tra i diversi generi artistici. Gli oggetti di scena, dicevamo, filmati dalla videocamera con perizia chirurgica e digitalizzati sul fondo in configurazioni geometrizzanti di compatta e accesa stesura cromatica, sono oggetti ‘poveri’, di uso quotidiano. La macchina, cui si avvicinano con grazia pulsante o zigzagando a ritmi convulsi, li trasfigura condensandoli in nodi e grovigli a rilievo dai colori violenti, in iridescenti e luminosissimi graffiti dalla densità variabile. Ecco allora un sasso di fiume divenire dorata esplosione fauvista in omaggio-richiamo all’Icaro di Matisse, la figura librantesi a mo’ di nube colorata entro la spazialità densa e sconfinata. Ecco ancora certi ninnoli infantili e ludici, come le festose cartine dell’uovo di Pasqua, farsi arazzi dai ritmi danzanti, dalla giocosità coriandolare e dalla poligonale allegria. Il processo formale è tutto additivo, ogni colore sostenendo gli altri in un crescendo espressionista di straordinaria forza plastica, secondo un metodo scompositivo a tasselli policromi che ricorda i contrasti scintillanti di argento, oro e smeraldi dei Boulevards di Gino Severini (si pensi al Dans du Pan-Pan à Monico o a certe Danseuses coperte di lustrini e paillettes) o, ancora, la propagazione e moltiplicazione dell’immagine generata dai quadri di Delaunay. La rappresentazione del dinamismo avviene in termini ottico-percettivi: gli oggetti scanditi in piccoli poligoni si spezzano, perdono segmenti, si frastagliano nel riverberare caleidoscopico di luci triangolari, nel tentativo di restituire allo spettatore un impulso dinamico puro, svincolato dalla sua origine oggettuale e che, attraverso il continuo variare delle radiazioni luminose, imprima una metamorfosi alla forma. Una scatoletta a foggia di cuore ci appare dapprima come pura esplosione di rosso vermiglio a fare da sfondo allo strazio amoroso di Orfeo, la campitura larga di colore a densità cangiante attraversata da repentini guizzi porpora. E’ soltanto nella scena finale che lo sfavillante cuoricino, dalle apparenze di festa irreale, si mostra nel suo valore d’uso ed emerge, a quel punto, stranamente focalizzato, ingrandito come in una tavola scientifica, quasi a voler rivelare la magia illusionista della ripresa in macro. Ad ulteriore riprova del portato stilistico di spoliazione, l’episodio dell’infelice cantore di Tracia non viene mai menzionato: esso è piuttosto agito plasticamente quando Marco Sodini/Orfeo, dimostrando grande sapienza attoriale, si blocca in posa isometrica e si gira in slow-motion a cercare sul fondo la sua Euridice. L’uomo, distante, sospende la versificazione del testo in una pausa di stupore e memoria e si sofferma a giocare sul filo dell’intenzione; è il mistero che nasce quando si realizza la presenza integrale di un attore. Nel frattempo l’improvvisazione musicale propone inaspettate texture di sintesi (suoni vetrosi e graffiati che provengono dalle più svariate fonti cibernetiche quali generatori di segnali radio, contatori geiger, sensori per la misurazione del battito cardiaco) giustapposte, in spregiudicata alternanza, a uno stralcio riconoscibile dell’Orfeo di Monteverdi. Il sound che ne scaturisce possiede una musicalità deviata e assurda che nasce dal campionamento del rumore di fondo scollato e restituito in sovversiva libertà sonora. In una conversazione successiva con Mauro Lupone (sound designer e docente di computer music), scoprirò che il suo lavoro si focalizza sul processamento del suono in digitale e sulla disgregazione morfologica dello stesso, ottenuta con tecniche miste tra cui processi di granulazione (Csound del MIT) per accentuare l’instabilità e la precarietà latente nel materiale sonoro.
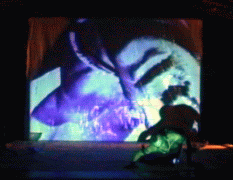
La sensibilità cromatica, davvero raffinatissima, ed il vitalismo luministico non sono le uniche note su cui si gioca il repertorio iconico dello spettacolo: immagini sporche, dai colori acidi di pellicola graffiata emergono su di un supporto inchiostrato, imitando turbini materici da frottage di elementi disparati, campionando in questo modo anche la casualità del segno. Lo spazio coagula in striature digitali; il segno si appresta a divenire erosione lasciando intravedere chiazze di écriture a campiture sabbiose, organiche nervature, coaguli ematici, strane infiorescenze di sfavillanti mitocondri. La psicogeografia dello spettatore si popola di ombre elettroniche, di linee rumoristiche inarmoniche caratterizzate dalla permanenza di gomitoli sonori, di bassorilievi di interferenze luminose flesse in zone chiare e oscure. L’ambiente sonoro, decriptato dall’evidenza del grafico, è dato adesso da arrovellii, da cirri mutevoli e industriali, dal rumore che resiste all’estinzione della fabbrica, ai suoi ritmi alienanti, ossessivi, lancinanti. E’ un giacimento di immagini e suoni che si richiama alla scena industrial (quella dei primi Einstürzende Neubauten o dei Throbbing Gristle), ai gruppi che perseguirono la sperimentazione musicale servendosi di materiali di recupero, riproponendo sul versante sonoro l’utilizzo di tecniche di bricolage e di cut-up mutuate dai dadaisti e da W.Burroughs. Appare chiaro che il principio di rottura asignificante che diede via alla guerra dell’informazione - la musica divenendo un pretesto per comunicare a più livelli, per utilizzare diversi media e diversi network in strategia catastrofica contro il sistema ed i suoi stessi simboli - è lo stesso principio di connessione dell’eterogeneo che informa l’andamento anarchico di questa tecno-performance. Un fenomeno spettacolare ibrido e difforme che, attraverso l’uso contrastivo dei supporti impiegati, attraverso il travaglio e la saturazione di materiali eterogenei, giunge ad un’affascinante transcodifica dei generi. La manipolazione dei testi, trattati alla stregua di cellule intercambiabili ed usati come reagente l’uno dell’altro, produce infatti una profonda contaminazione tra codici letterari, iconici e sonori; lo spiazzamento che ne deriva è dovuto alla complessità dell’ambiente fisico e relazionale, al rapporto di instabilità tra corpo reale, figure virtuali e ambiente di risonanza.

La vera complessità di questo evento/spettacolo risiede però soprattutto nella grazia che gli deriva dalla sua semplicità; anche il dispositivo scenico, nella scarna essenzialità del décor, sembra congegnato ad arte per palesare il tecnologico, per suggerire una poetica della trasparenza nel rapporto tra scena e platea. La mediazione tecnica infatti, rimpiazzando il rapporto tra i personaggi o quello esclusivo tra attore e spettatore, fa sì che l’opera ritrovi un’immediatezza nella trasparenza dell’interfaccia, nel feedback interattivo degli strumenti di scena. Ciò è ravvisabile nella postazione stessa dei tre tecno-artisti - operanti con macchine informatiche a vista - il cui performarsi interattivo comporta una definizione della scena come luogo della compresenza, della contiguità dell’azione, delle strategie di connessione. La conseguenza più immediata di questa pienezza è la materializzazione di un piano di pura immanenza dove i ruoli gerarchici sono contraddetti o azzerati, dove si realizza uno stato di divenire assoluto. Ascolto e visione sono puro accadere. La curva emozionale intensa che accompagna lo spettatore durante lo svolgersi dello spettacolo, declina infine verso un’apertura percettiva amplia e indefinita. E’ a questo punto che lo sguardo sensibile si affaccia su remoti paesaggi interiori e le metamorfiche presenze sintetiche assumono i contorni di trascendentali agnizioni, di immaginali attraversamenti dell’anima.
Scarica il video (1' 23")
Formato mpg 13,7 MB
Real Player 1,37 MB
Windows MV 1,55 MB
LE SEGNALAZIONI DI TNM
ARS ELECTRONICA 2002
Linz, 7-12 settembre
UNPLUGGED
Art as the scene of global conflicts
Workshop su "Storytelling in Collaborative Virtual Environments"
Workshop at the ACM CVE2002
30 September 2002
Bonn, Germany
Call for Participation
Description
Virtual storytelling concepts provide opportunities to engage the users in activities in virtual environments and to enhance the content presented through the environment. This workshop will focus on the requirements, generation and effects of storytelling in CVE's. We will examine scenarios for storytelling, consider design issues and methods for the generation of narratives, and discuss the impact of storytelling on the interaction in virtual environments.
Themes
Themes may include "What makes a good story - content vs. technology capability", "Design issues in collaborative storytelling", and "Supporting the emergent story-who's story is it anyway?" Position papers should address one of the following topics:
* Which kinds of activities have been proven useful for representation in collaborative storytelling?
* How do we generate stories based on activities in shared spaces?
* How do we develop a storyline? What makes a 'good' story?
* Story development by characters vs. story development by script?
* What are the design issues in collaborative storytelling?
* How do we interact with narratives in shared environments? What is the role of narrative?
* Does all the storytelling have to take place within the environment in a CVE?
Organisation
We will conduct three (very interactive) panel presentations and small and large group discussion sessions, followed by a wrap-up discussion session on future directions. Each panel will consist of 5-6 short talks given by a subset of workshop attendees, and followed by intensive discussion by the entire group. Each attendee will give a brief (refereed) talk of one of the panels and participate in the audience discussion for the other two panels. Speakers on the panels will present existing collaborative storytelling applications and discuss requirements to combine collaborative activities with storytelling.
The workshop will close with a group discussion session chaired by the organizers, in which we will focus on highlights and interconnections between the three panels. The results will be prepared as a poster for the conference poster session. We plan to publish a summary of the workshop and selected position papers in the SIGGROUP bulletin.
Participation
Workshop participants are requested to submit a 2-4-page position paper that addresses the topic of the workshop. The workshop participants will be selected based on these position papers. Acceptance of applications will be based on the quality of the work proposed for presentation and its relevance to the workshop. Participants will be limited to 20-25 people.
Participants will have opportunities before arriving to the workshop to get to know each other, and become familiar with the topics being presented. We plan to maximize interpersonal interactions by suggesting that workshop participants have lunch and dinner together.
Send submissions to: cve2002-storytelling@fit.fhg.de
Important Dates
6 September 2002 : Position Paper Submission Deadline
15 September 2002 : Notification of Acceptance
30 September 2002 : Workshop on Storytelling in CVE's
Workshop Organizers
Léonie Schäfer, Fraunhofer Institute FIT, Germany
Dr. Elaine Raybourn, Sandia National Laboratories, USA
Amanda Oldroyd, BTexact Technologies, UK
Dr. Kurt Fendt, MIT Comparative Media Studies, USA
Contact
Léonie Schäfer
Fraunhofer FIT
Schloss Birlinghoven
53754 Sankt Augustin
Germany
Email: cve2002-storytelling@fit.fhg.de
Web: http://www.cve2002.org/cve2002-storytelling.html
|


